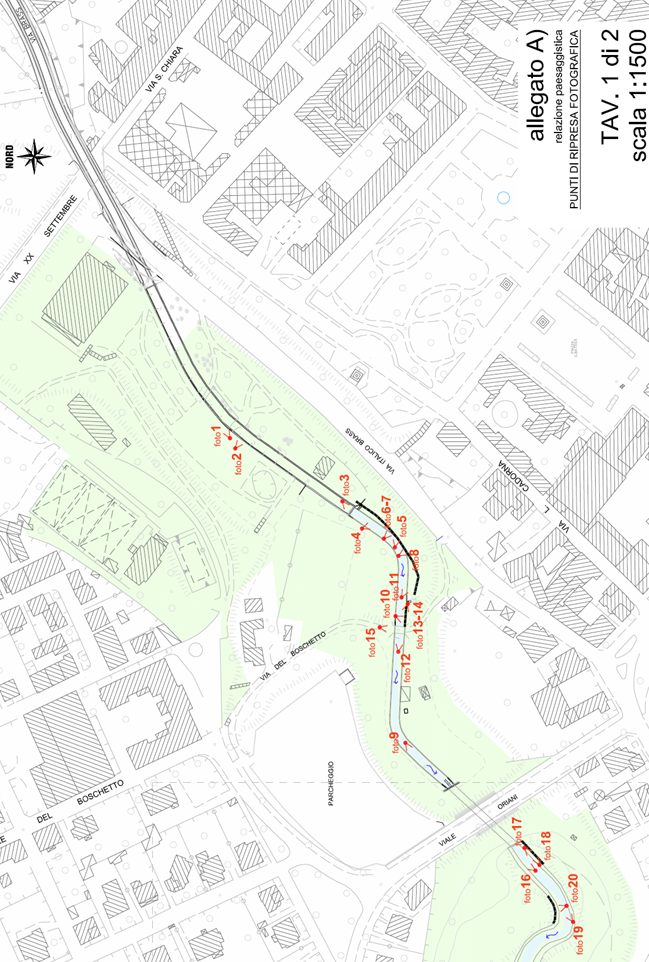Il Progetto sloveno riguarda: la
raccolta e trattamento delle acque reflue nel bacino del fiume Isonzo -
Impianto centrale di trattamento delle acque reflue per la città di Nova Gorica
e localita Šempeter, Vrtojba e Miren (50 500 AE) e della adeguata
ricostruzione del sistema fognario misto (approvato ottobre
2012, la realizzazione è iniziata nel 2014, l’ultimazione è prevista nel 2015)
Le città di Nova Gorica, Sempeter, Vrtojba e
Miren sono ancora senza un adeguato sistema per il trattamento dello scarico
delle acque reflue. Gli interventi di progetto sono attualmente in fase di
realizzazione.
L’intervento è finanziato in parte (circa il
69%) dai fondi di coesione UE, con stima finale dei costi di investimento pari
a circa 48.5 Mio € (IVA del 20% inclusa).
Nelle città di Nova Gorica, Šempeter e
Vrtojba la rete fognaria è di tipo misto. La lunghezza totale della rete
fognaria nell'area del progetto è di 137.5 km. I problemi sono per lo più legati all’assenza
di depurazione, all’inadeguato funzionamento delle vasche di ritegno della
prima pioggia, degli sfioratori e alle tubazioni sottodimensionate (protezione
dalle inondazioni non idoneo allo standard Europeo EN 752-2 richiesto).
Tenendo conto anche delle attività
industriali e commerciali nel area di Šempeter e Vrtojbe e del carico biologico
e idraulico proveniente dal paese di Miren, il totale carico biologico attuale
ammonta a circa 40 500 AE con una portata idraulica pari a Qm = 439
l/s (con acque parassite di infiltrazione pari a circa 86 l/s – circa il 54%
della porta media giornaliera). Tenendo conto del sviluppo previsto del area
interessata (basandosi su studi demografici ed economici) il carico biologico
previsto (nel 2038) è stato aumentato a 50 500 AE, con portata idraulica
prevista pari a Qm = 536 l/s (con acque parassite di
infiltrazione pari a circa 106 l/s – circa il 54% della porta media
giornaliera). Il mantenimento della stessa quota proporzionale delle acque
parassite di infiltrazione (il 54% della porta media giornaliera) consente una riserva di gestione della portata
idraulica dell’impianto di depurazione una volta risolto questo problema.
Con il nuovo sistema fognario e con la costruzione
dell'impianto di trattamento, i comuni di Nova Gorica, Miren - Kostanjevica e
Šempeter - Vrtojba raggiungeranno i seguenti obiettivi:
Obiettivi primari:
- Collegamento di 10 263 AE
supplementari alla rete fognaria in tutti gli agglomerati interessati (nel
2015).
- Riduzione del carico biologico
nelle emissioni nei fiumi Corno, Vrtojbica, Vipacco ed Isonzo per
42 000 AE.
3.
Aumento
del numero di agglomerati (con carichi superiori a 2000 AE) equipaggiati con la
raccolta e il trattamento delle acque reflue (per 4 agglomerati aggiuntivi).
Obiettivi secondari:
- Costruzione di infrastrutture
per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane.
- Bonifica delle fonti di
inquinamento esistenti da insediamenti nei comuni interessati.
- Collegamento di 42 000 AE
e di tutti gli agglomerati interessati all'impianto di trattamento delle
acque reflue.
- Costruzione e aggiornamento del
sistema fognario misto per una lunghezza complessiva di circa 18 km.
5.
Costruzione
di un impianto di trattamento delle acque reflue e prima pioggia con una
capacità complessiva di 50 500 AE e portata idraulica di circa 536 l/s
(WWTP Nova Gorica).
Inoltre il progetto persegue i seguenti obiettivi strategici e
operativi:
- Attuazione delle misure
necessarie al fine di raggiungere i principali obiettivi (buono stato
ecologico) della Direttiva quadro sulle risorse idriche (2000/60/ES) sui
fiumi Vipacco e Isonzo, (tra cui gli affluenti Koren e Vrtojbica) e del
golfo di Trieste.
2.
Instaurazione
di un sistema permanente della raccolta e trattamento delle acque reflue per
tutta la popolazione del bacino del fiume Isonzo nei comuni interessati.
Per raggiungere gli obiettivi fissati sono state previste le seguenti
soluzioni tecniche:
- Costruzione di un impianto
centrale di trattamento delle acque reflue con tecnologia di fanghi
attivi, riduzione dei nutrienti (azoto e fosforo) e disinfezione delle
acque trattate. L’impianto, in costruzione, è previsto con la seguente tecnologia:
- membrane di ultrafiltrazione
(MBR),
- rimozione dell’azoto e fosforo,
- sito di ricezione delle fosse
settiche per 2 000 AE (48 m3 di fanghi / giorno),
- stabilizzazione dei fanghi
aerobica (aerazione prolungata) con ispessimento (disidratazione) e essiccazione
dei fanghi (min. 90% di solidi secchi) – carico biologico pari a
80 000 AE,
- disposizione finale dei
fanghi: incenerimento – in outsourcing,
- rimozione degli odori – biofiltro,
- portata idraulica prevista – Qm = 536
l/s,
- carico biologico di 50 500 AE.
- L’adeguamento del sistema fognario
misto prevede le seguenti soluzione tecniche:
- Ampliamento delle dimensioni
delle tubazioni fognarie miste per raggiungere un livello di protezione
dagli allagamenti richiesto dallo standard Europeo EN 752-2 (pari ad
eventi con un tempo di ritorno dai 20 ai 30 anni). Sono previste
tubazioni per un lunghezza di circa 18 km in vetroresina (PFRV) con
diametri da 400 a 1400 mm.
- Il controllo delle portate
verso il depuratore provenienti dagli sfioratori e dalle vasche di prima
pioggia è previsto mediante sistemi di controllo dei flussi (progettate
per funzionare in modo completamente meccanico).
- Per ridurre l’impatto
ambientale delle acque sfiorate, tutti gli sfiori (in totale 26) e le
vasche di ritegno della prima pioggia esistenti e previste (in totale 5)
saranno dotate di sistemi di grigliatura.
Il progetto
approvato prevede:
a)
Per il depuratore:
1.
L’utilizzo
di fanghi attivi sospesi, con riduzione dei nutrienti : azoto e fosforo e ultrafiltrazione a membrane.
2.
Fornisce
una qualità di depurazione non eguagliabile con altre tecnologie. La qualità
delle acque depurate è fondamentale in quanto il fiume destinatario (torrente
Vrtojbica), presenta un rapporto di diluizione piuttosto limitato. Nella tecnologia
a membrane la separazione dell'acqua trattata e i fanghi attivi avviene per
mezzo di una membrana con porosità di 0.4-0.04 micron. Tali piccoli pori
rappresentano un ostacolo fisico alle particelle. Il risultato è un scarico nel
fiume destinatario senza materiale in sospensione (TSS = 0 mg/l). Nessuna delle
altre tecnologie utilizzabili per depuratori per acque reflue riesce a
raggiungere tali risultati per quanto riguarda la rimozione dei materiali in
sospensione. Tali risultati non potrebbero essere raggiunti nemmeno con l’utilizzazione
di filtrazione come pretrattamento necessario per una efficace disinfezione UV.
Il problema principale è nella porosità dei filtri a 10-100 micron, che li
rende permeabili a particelle più piccole.
3.
La
stabilizzazione dei fanghi aerobica (aerazione prolungata) consente di avere un
impianto di depurazione meno impattante (manufatti più contenuti e footprint
inferiore), impianto più semplice da gestire e con minore dispendio di
manodopera. La linea dei fanghi è prevista con ispessimento (disidratazione) e
essiccazione dei fanghi (min. 90% di solidi secchi), per un carico biologico
par a 80 000 AE (possibilità di trattare i fanghi da un bacino d’utenza più
grande). Il fango così ridotto rappresenta poi una fonte energetica che potrà
essere utilizzata in svariati modi.
b)
Per la rete fognaria:
1.
L’adeguamento
delle dimensioni delle tubazioni fognarie miste è previsto con tubazioni in
vetroresina (PRFV) con diametri di 400 a 1400 mm (SN 10 000). Il controllo
delle portate verso il depuratore dagli sfioratori e dalle vasche di prima
pioggia e previsto tramite sistemi di regolazione dei flussi di produzione
tedesca (costruiti in acciaio AISI 304), con funzionamento completamente
meccanico, senza energia elettrica. L’energia viene fornita dall’energia
idraulica (potenziale e cinetica) della portata idraulica nel sistema fognario.
L’installazione dei controlli di flusso consente una regolazione delle portate
dagli sfiori verso le vasche di ritegno della prima pioggia e al depuratore. In
tal modo viene garantita una diluzione delle acque sfiorate pari ad almeno
min. 7 volte (una parte di acque nere su sette parti di portata sfiorata).
Per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale delle acque sfiorate tutti gli
sfiori e vasche di ritegno della prima pioggia esistenti, previste e le vasche
di ritegno della prima pioggia esistenti e previste (in totale 5) saranno
dotate di sistemi di grigliatura. Anche questi saranno dotati di un sistema
autopulente senza bisogno d’energia elettrica.
c)
Per i ricettori finali, Vrtojbica e
Corno:
1.
l’alta
qualità del acqua depurata consentirà di rivitalizzare l’habitat aquatico del torrente
Vrtojbica. Mentre il torrente Corno sarà totalmente “sgravato” dell’attuale
scarico di acque reflue, esclusi gli eventi di sfioramento delle acque piovane
(diluzione pari ad almeno 7 volte).
Per la redazione del progetto è stato
sviluppato un modello idraulico e
idrologico dell’intero sistema fognario della città di Nova Gorica e delle
località di Šempeter e Vrtojba. Il modello matematico e stato realizzato con
l’uso del software SWMM 5.0 (US EPA). Il modello comprende circa 190 km di
fognature di tipo misto, con 29 sfioratori, 7 vasche di ritegno della prima
pioggia e 10 stazioni di pompaggio. Il bacino d’utenza (idrografico) comprende
circa 2050 ha di area urbanizzata e non, con un carico biologico di circa
50 000 AE. Il deflusso superficiale e stato modellato in modo dinamico con
il processo d’infiltrazione modellato con l’equazione di Horton. Mediante
un’analisi a moto vario (“dinamic wave”) è stata determinato il grado di
capacità di deflusso all’interno della rete fognaria. Tuti gli interventi
previsti sulla rete fognaria sono stati successivamente immessi nel modello
dello stato attuale della fognatura mista. In tal modo si è creato un modello
dello stato della fognatura del futuro prossimo. Cosi si sono potuti verificare
gli effetti reali sulla capacità di deflusso all’interno della rete fognaria e
il livello di protezione dalle inondazioni realmente raggiunto.
Il depuratore è stato progettato secondo lo
standard Tedesco ATV-DVWK-A 131 che garantisce un punto di partenza validissimo
per il buon ed efficace funzionamento del depuratore. Il modello matematico è
stato realizzato utilizzando il software GPS-X della Hydromantis.
E’ stata condotta una campagna di rilievo dello stato di fatto delle
portate nel sistema fognario di Nova Gorica. Sono stati effettuati rilevamenti
continui della portata delle acque reflue nel periodo dal 22.4.2009 al
23.6.2009 (con un intervallo di campionamento di 3 minuti) e rilevamenti della
quantità di precipitazioni nel bacino d’utenza. Su talli dati è stata fata una
calibrazione e successiva validazione del modello matematico. Sulla base degli
scarichi misurati nella rete fognaria (per un lungo periodo di tempo secco) e
della quantità di acqua potabile venduta nel periodo stesso, è stato possibile
determinare l'apporto effettivo delle acque parassite d’infiltrazione e la
portata oraria massima di picco. Contemporaneamente ai rilevamenti delle
portate delle acque reflue è stato effettuato il campionamento di composizione
delle acque reflue (COD, BOD5, P, N, TSS), con una frequenza di
campionamento di 2 campioni per ora (48 prelievi al giorno). La composizione
dell'acqua è stata campionata due volte (29.4.2009 e 27.5.2009). Sulla base di
questi campioni e contemporanee misure di portata è stata effettuata un analisi
di bilancio di massa per COD, BOD5, P, N e TSS.
1. sistemi adottati per garantire il funzionamento degli impianti e per ottenere il massimo rendimento e la massima sicurezza degli impianti stessi
Il massimo rendimento e sicurezza del funzionamento del depuratore di
Nova Gorica sarà garantito dai:
- Flessibilità della tecnologia
MBR, Due linee parallele di grigliatura (ognuna prevista per il 100% del
carico idraulico), Due linee parallele di dissabbiatura e degrassatura
(ognuna prevista per il 50% del carico idraulico), Quattro linee parallele
della fase biologica (anossica/anaerobica, aerobica) con 3 compressori (2
in funzione, 1 in stand-by), Otto linee parallele di membrane con 3
compressori (2 in funzione, 1 in stand-by), Due linee di ispessimento
(disidratazione) dei fanghi (capacita per trattare la quantità settimanale
di fanghi in 5 gironi lavorativi), Una linea di essicazione dei fanghi
(capacita per trattare la quantità settimanale di fanghi in 4 gironi lavorativi),
La fase di pretrattamento della linea dell’acqua e la linea dei fanghi è
al coperto in depressione, con la connessione a un filtro (biofiltro) per
l’aria.
- Il depuratore sarà dotato di un
motore diesel per produrre energia elettrica in caso di mancanza della
stessa. Il motore produrrà energia elettrica in sufficienza per far
funzionare la linea dell’acqua del depuratore.
- I sistemi di controllo dei
flussi e le griglie nelle vasche di ritegno della prima pioggia e negli
sfioratori sono previsti come autopulenti, senza necessità di energia
elettrica. L’effetto autopulente è garantito dalla pressione dell’acqua.
2. monitoraggio in continuo dei parametri idraulici, depurativi ed energetici
Il depuratore è previsto con un sistema
elettronico per misurare la portata, pressione e l’energia elettrica. Esso sarà
collegato con il sistema SCADA che registrerà tutti i dati necessari per il
controllo del processo e l'ottimizzazione dei costi del processo di
depurazione. Misurazioni di portata e caratteristiche del refluo sono previste
nei seguenti punti: sfiori di sicurezza delle acque piovane dalle vasche ti
ritegno della prima pioggia, pompa d’ingresso al depuratore, misurazioni per
ogni linea biologica, cioè dopo la fase di pretrattamento, misurazioni dopo
ogni linea del reattore delle membrane, misuratori di portata per l'acqua di
ritorno per ogni reattore separatamente; misurazione della pressione d’ingresso
e uscita sulle membrane (per ogni reattore a membrana), riciclo dei fanghi
attivi per reattori anossici, fanghi in eccesso trasmessi al trattamento dei
fanghi, consumo dell’acqua potabile, tutte le linee di dosaggio per polimeri e
prodotti chimici, consumo di energia elettrica per le membrane; consumo di
energia elettrica per soffiatori.
Il campionamento di parametri nel processo biologico è automatizzato ed
installato nelle seguenti posizioni:
·
campionamento
delle acque reflue non trattate (prima della fase di trattamento biologico),
·
campionamento
delle acque reflue trattate (dopo le membrana di ultrafiltrazione).
I sensori per la raccolta di campioni tal quale, contestualizzati alla
portata misurata all’atto del prelievo, saranno stoccati in un contenitore per
il campionamento composito. Tutti i campioni saranno racchiusi (sotto chiave)
in un armadietto, climatizzato e resistente agli agenti atmosferici. Per il
controllo in continuo (online) del processo di depurazione, l'impianto sarà
dotato di un apparecchiatura di elaborazione di alta qualità. Per un corretto
controllo del processo, è previsto di garantire almeno: Sensore differenziale
digitale per la misura del pH e della temperatura; Analizzatore di ammoniaca
con un involucro isolato resistente agli agenti atmosferici (temperatura
interna controllata per installazione interna o esterna); Sistema di filtrazione
per montaggio esterno o interno per la preparazione del campione filtrato (per
ammoniaca) senza particelle e batteri; Sensore (per COD) ottico digitale per la
misurazione della SAK; Campionatore stazionario automatico (per COD) per la
raccolta di campioni rappresentativi secondo la norma ISO 5667; Sensore
digitale per ossigeno disciolto (almeno 3 pezzi per linea) realizzato con
materiali resistenti alla corrosione, completamente sommergibile; Sensore
ottico digitale per la misura di nitrato; Sensore di ortho-fosfato con
involucro isolato e resistente agli agenti atmosferici, temperatura interna
controllata, per installazione interna o esterna; Sistema per la preparazione
di un campione omogeneo per analizzatore fosforo; Sensore ottico digitale per
la misurazione di opacità o solidi sospesi (concentrazione dei fanghi e TSS
dell’acqua).
L’installazione dei sensori per il controllo del processo di depurazione
e prevista sia all’ingresso, che nella fase biologica della depurazione e alla
fine del processo.
Sono previsti moduli per i sensori per il collegamento locale dei
sensori digitali e analizzatori. I moduli comunicheranno con il sistema di
controllo SCADA.
3. automazioni con sistemi “SMART”
Il controllo remoto e monitoraggio dei processi sarà effettuato nel
centro di controllo all'interno dell'edificio amministrativo accanto al
trattamento delle acque reflue.
L'unità di controllo centrale (e periferiche associate) sarà situata nel
centro di controllo. Singoli apparecchi e attrezzature all'interno del processo
della depurazione delle acque reflue saranno controllati da unità di controllo
locale, che sarà interoperabile e collegabile con l'unità di controllo centrale
in un sistema di controllo globale basato su una gerarchia del tipo a “stella”.
Tutte le unità di controllo utilizzate saranno programmabili con un codice
aperto.
L’hardware del centro di controllo supporterà la ridondanza (a livello
delle unità di potenza, le sezioni di server, unità disco, comunicazioni,…). In
tal modo sarà garantito un funzionamento affidabile del sistema informatico.
Il software sarà realizzato con la tecnologia di virtualizzazione (ad
esempio VMware) con controllo visivo di tutte le funzioni del processo,
gestione dei processi manuali, memorizzazione e la visualizzazione dei dati ed
attivazione di allarmi. L’attivazione degli allarmi sarà regolabile per zone di
allarme e per ciascun punto di I/O. Il ritorno delle informazioni agli
operatori sugli stati degli allarmi di sistema verrà effettuata in diversi
modi: visualizzazione sullo schermo, per liste d’allarmi, per segnale acustico,
con l'invio delle e-mail, invio selettivo di messaggi SMS.
Il centro di controllo potrà comunicare con più vie simultanee (radio,
PSTN, connessione cablata fissa, Ethernet, GPRS, 3G).L’archiviazione dei dati
sarà eseguita nel database con l'elaborazione statistica dei dati di processo.
Il sistema consentirà la modifica dei parametri dal centro di controllo.
Il PLC e altre attrezzature saranno collegate tra di loro. Per un funzionamento
più affidabile del sistema di controllo, quest'ultimo sarà alimentato dalla
sorgente di alimentazione continua attraverso la protezione da sovratensione
appropriata.
P.S. tutte le informazioni riportate sono state ricavate dai dati del
progetto posto a base di gara. Ora l’affidamento con il criterio dell’appalto
integrato può avere portato a delle migliorie anche significative che
conosceremo al termine della costruzione.
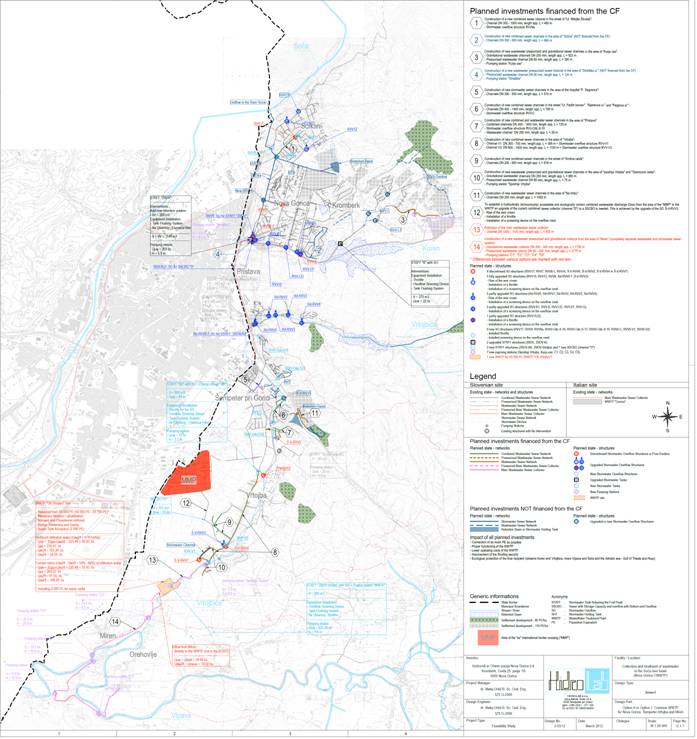
B)
Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del
torrente Corno e del suo bacino -
RINATURALIZZAZIONE DI ALCUNE ZONE CRITICHE
b.1) criticità dello stato di fatto
Il
torrente Corno nasce in territorio sloveno, oltrepassa il centro abitato di
Nova Gorica e dopo pochi chilometri entra in territorio italiano attraversando
la città di Gorizia per poi confluire nel fiume Isonzo. Il Corno riceve in
Slovenia, ed in particolare da tutta l’area urbana di Nova Gorica, liquami
fognari non depurati sia di origine civile (o ad essa assimilabile) sia
scarichi di tipo industriale, trasformando di fatto, nel territorio italiano,
il torrente in una fognatura a cielo aperto.
Nel corso degli ultimi anni sono stati
effettuati degli interventi di emergenza, volti a trasferire i liquami al
depuratore di Gorizia, permettendo un minimo di sicurezza igienica.
Questo scelta, comporta notevoli problematiche al depuratore, sia in
termini di costi energetici sia in termini di qualità della depurazione. Va
inoltre evidenziato come gli interventi realizzati non siano ad ogni modo in
grado di canalizzare la totalità del refluo verso il depuratore, lasciando
transitare verso l’Isonzo una quota parte delle acque nere in transito
all’interno del Corno.
Trattasi infatti di soluzioni di emergenza,
non completamente risolutive del problema. In aggiunta, ampie aree della città di Gorizia
attraversate dal Corno subiscono allo stato attuale, oltre al problema
sanitario già descritto, anche l’esposizione al rischio di allagamento. A
seguito di diverse riunioni della Commissione Italo-Slovena per
l’idroeconomia sono state ricercate soluzioni al problema. Il
progetto in oggetto ha quindi dovuto essere in grado di rispondere ad uno
scenario estremamente grave ed in continuo mutamento in quanto legato alle
scelte dei singoli paesi. Infatti a seguito dell’ingresso nella UE la Slovenia
ha scelto di procedere alla costruzione del suo depuratore a Nova Gorica.
Pertanto nel 2010, comunicava alla parte italiana che in base ad una
riprogettazione della rete fognaria di Nova Gorica e degli interventi di
trattenuta delle piene già realizzati nel bacino del Corno in SLO (bacino del Pikolud), la
portata di piena massima centenaria al confine italo-sloveno veniva rideterminata in massimi 30 mc/s rispetto ai 60-70
mc/s stabiliti negli accordi precedenti che avevano dato luogo alla progettazione
del 2002. Pertanto tale modifica comportava l’abbandono della galleria scolmatrice prevista con il progetto del
2002.
L’eccedenza della portata in arrivo dalla
SLO rispetto a quella compatibile con le attuali
sezioni del Corno sotterraneo viene raccolta da una nuova condotta
microtunnelling (già prevista nel
progetto del 2002), incrementata di diametro. Sulla
base di queste modifiche il progetto consente di rispondere alle problematiche sopra evidenziate sia
nell’immediato, sia a lungo termine grazie alla possibilità di intervenire in
alcuni punti chiave del sistema di gestione ed allontanamento delle acque
studiato. Inoltre è importante evidenziare la capacità del progetto di
riconsegnare alla popolazione di Gorizia vaste aree della città attualmente del
tutto abbandonate a causa dell’inquinamento esistente. In quest’ottica il
progetto prevede la realizzazione del Parco della Valletta, nuovo polmone verde
della città completamente risanato e nuovo punto di aggregazione per la
cittadinanza.
1. Il progetto esecutivo, approvato dalla regione FVG nel 2014, prevede di raggiungere i seguenti risultati:
- la
messa in sicurezza idraulica di Gorizia da possibili
esondazioni del Corno provenienti dal territorio Sloveno;
- il
risanamento igienico del torrente mediante l’eliminazione degli apporti di
acque nere sia in territorio Sloveno che Italiano, grazie a:
-
da parte dell’Amministrazione Slovena con la
realizzazione del depuratore delle acque reflue dell’abitato di Nova Gorica
(opera già in corso di
costruzione);
-
in territorio italiano con il risanamento e
rifacimento delle condotte della fognatura nera che si sviluppano lungo il
torrente Corno e sono collegate alla rete del depuratore di Gorizia.
- la
riqualificazione
naturalistico-ambientale del parco della Valletta nel cuore della
città con indubbi vantaggi per la qualità dell’ambiente e con la
riqualificazione dal punto di vista paesaggistico di un settore urbano
oggi trascurato ed inutilizzato;
- la
conseguente eliminazione delle emissioni maleodoranti attualmente
percepibili nelle vicinanze dei tratti aperti del torrente, con indubbio
miglioramento della qualità della vita per i residenti in un ampio settore
della città.
2. Gli interventi progettati e le finalità in esso contenuti sono:
- Realizzare
una galleria sotterranea in grado di garantire la sicurezza idraulica del
territorio italiano a causa delle esondazioni del torrente Corno in
territorio Sloveno ed evitare dannosi allagamenti della città di Gorizia
come più volte avvenuto nel recente passato. Tali lavori
sono relativi alla condotta realizzata con la tecnica costruttiva del
microtunnelling e nello specifico sono costituiti da:
–
manufatto di imbocco e collegamento sul
torrente Corno, subito a valle dell’ingresso dello stesso in territorio
italiano. Esso ha la funzione idraulica di intercettare la portata di magra in
arrivo dal tratto sloveno del torrente Corno e di consentire la sua deviazione
all’interno della nuova condotta sotterranea.
–
condotta di collegamento delle acque meteoriche
del torrente Corno, con la nuova condotta sotterranea realizzata secondo la
tecnica del microtunnelling che a sua volta trasferisce le stesse acque
nell’alveo a cielo aperto del Corno nel parco della Valletta;
–
manufatto di raccolta delle acque di piena di
allagamento provenienti dalla Slovenia, presso il confine di Stato di via San
Gabriele. Questo manufatto si rende necessario in attesa della realizzazione da
parte del Governo Sloveno della struttura di collegamento tra il torrente Corno
in Slovenia e la galleria sotterranea prevista in territorio italiano. Ha il
compito di raccogliere le portate di allagamento e di inviarle alla condotta
sotterranea, impedendo l’inondazione del comune di Gorizia;
–
condotta realizzata con la tecnica del
microtunnelling avente il diametro di 2000 mm;
–
vasca di dissipazione e restituzione, che si
immette nel tratto di torrente Corno a cielo aperto (presso il parco della
Valletta) a valle della condotta sotterranea.
- Garantire
l’impermeabilizzazione e il risanamento del collettore fognario esistente,
posto all’interno del tratto ricoperto del Corno ed appartenente alla rete
fognaria di Gorizia, al fine di impedire dannose infiltrazioni nel suolo
delle acque nere e quindi impedire l’inquinamento del sottosuolo e delle
acque di falda. Infatti lo stato precario della condotta esistente
pregiudica il buon funzionamento della stessa.
- Garantire
che le acque bianche di magra, provenienti dal bacino del Corno sloveno,
possano defluire lungo il tratto del Corno a cielo aperto senza essere
contaminate da scarichi di acque nere della città di Gorizia;
- La
riqualificazione igienica del torrente Corno richiede anche
l’intercettazione ed il collegamento degli esistenti scarichi di acque
nere lungo il tratto sotterraneo del torrente Corno con le tubazioni della
rete fognaria esistenti.
- Riqualificazione e
rinaturalizzazione del tratto di torrente ricadente all’interno del parco urbano della “Valletta”.
La
Valletta
La
Valletta del Corno, intesa come insieme di aree verdi a diversa connotazione, è
articolata (da monte a valle) nel seguente modo:
- il Giardino Pubblico
della Valletta del Corno di proprietà comunale: il torrente Corno vi
scorre tombato, in alveo cementato mentre sulla copertura si trova una
superficie prativa;
- l’area tra il
Giardino Pubblico della Valletta del Corno ed il viale Oriani,
comprendente una piccola area verde rurale in sponda destra del torrente e
settori di boscaglia in scarpata nella parte finale. Il torrente Corno vi
scorre a cielo aperto, in alveo canalizzato cementato;
- la vasta area verde a
prevalente connotazione rurale che si estende tra i viali Oriani e
Colombo. Il torrente Corno vi scorre a cielo aperto, in alveo naturale.
Superato l’insieme delle aree
verdi della Valletta, il Corno entra nella vecchia zona industriale di Straccis
e, nuovamente tombato e con alveo cementato, inizia il suo tratto terminale
che, dopo poche centinaia di metri, sfocia nell’Isonzo all’altezza di via Lungo
Isonzo Argentina.
Cenni storici
Esaminando le mappe della città
dei secoli passati si può constatare come l’espansione della città abbia
modificato i caratteri morfologici del territorio attraversato dal Corno e come
ne condizioni ora il recupero e le possibilità di sistemazione e di
valorizzazione.
Nella mappa del 1832, riportata
sotto, il corso del torrente si presenta scoperto lungo tutto il tratto in
argomento con i soli attraversamenti dei ponti che collegano la città vera e
propria ai borghi esterni: Borgo Carinthia a nord e Borgo Piazzutta a
nord-ovest.
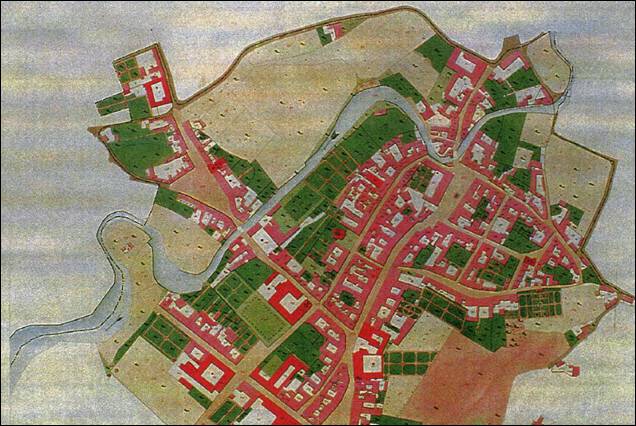
Figura 3: assemblaggio Mappe Gorz und
Prestau (1822) – Archivio di Stato di Gorizia.
Nella mappa del 1898
(Demarteau), non si registrano sostanziali variazioni nell’assetto
geomorfologico della Valletta, nonostante l’espansione dei borghi esterni: Piazzutta, Carinthia, Grafenberg,
Strazig.
In ogni caso, nel corso del
secolo XIX vengono costruiti ulteriori attraversamenti del Corno, come quello
in corrispondenza di piazza Corno (oggi Largo Pacassi) e quello di via del
Torrente per collegare Borgo Carinthia alla strada dietro il Castello (attuale
via Giustinuani). Si tratta dell’attuale via Corsica, destinata a sostituire il
percorso più antico (che molto probabilmente portava a un guado) di via del
Molino - via della Cappella, ed a collegare la piazza Catterini con la via dietro
il Castello.
Inoltre la necessità di
collegare con un percorso più agevole la città al ponte sull’Isonzo aveva
comportato nella prima metà del secolo XIX la costruzione della via del Ponte
Nuovo (attuale Viale XX Settembre), con il ponte in pietra e con il rilevato
attraverso la Valletta. Quest’ultimo rappresenta un primo sbarramento che
interrompe la continuità della Valletta del Corno, continuità che, nel corso
del secolo XX, ed in particolare nel primo dopoguerra, sarà ulteriormente
interrotta con la costruzione di viale Oriani e di viale Colombo sulla base
delle indicazioni del Piano di ricostruzione della città del 1921.
Questi sbarramenti realizzati
con materiali provenienti da demolizioni e con conseguente canalizzazione di
alcuni tratti del corso d’acqua, frazionano la Valletta dal ponte di Piazzutta
alla confluenza nell’Isonzo in quattro settori dai quali non si percepisce più
la continuità dell’avvallamento e del corso d’acqua.
Le modalità, con le quali sono
stati realizzati gli attraversamenti stradali hanno ulteriormente influito
negativamente sull’assetto dei luoghi e sulle caratteristiche paesaggistiche di
questo settore dell’ambito urbano. All’inizio del secolo XX anche la
costruzione della via S.Pellico aveva comportato un ulteriore canalizzazione
del Corno già in parte tombato in prossimità di Palazzo Attems e della porta
del Ghetto (Largo Pacassi).
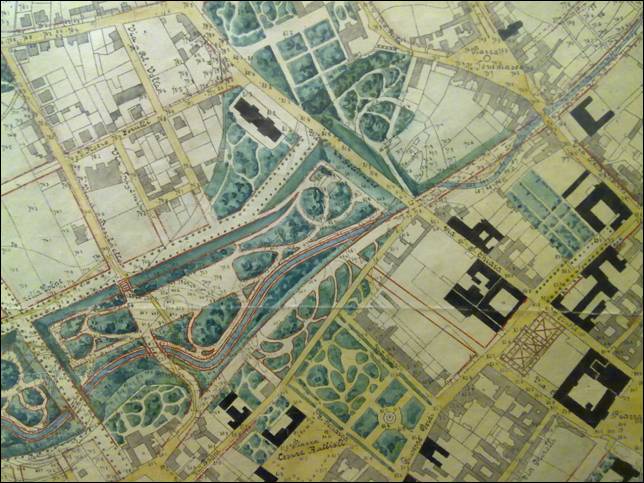
Figura 4: Piano di ricostruzione della
città risalente al 1921, da viale XX settembre a viale Oriani. Già al tempo gli
accessi al parco della Valletta erano pensati lungo via Italico Brass, da via
del Boschetto, dal passaggio L.L. Zamenhof.
L’attuale progetto definitivo
prevede le stesse vie di ingresso al parco e gli stessi percorsi di
attraversamento principali del parco.

Figura 5: Piano di ricostruzione della
città risalente al 1921, da viale Oriani al viale Cristoforo Colombo.
Indubbiamente, però, gli
interventi più consistenti di trasformazione paesaggistica del corso del
torrente si realizzarono nel secondo dopoguerra, quando, con la costruzione
della via Italico Brass, tutto il tratto del corso d’acqua dal confine di Stato
alla Valletta viene incanalato e tombato. Il progetto predisposto dall’Ufficio
Tecnico del Comune di Gorizia, porta la data del 8 febbraio 1950.
Nel 1964 il Comune di Gorizia
predispone un’ulteriore progetto di copertura del torrente Corno nella Valletta
per l’ampliamento del giardino pubblico. In seguito alla realizzazione di
questo intervento il corso del torrente risulta coperto per circa 1700 ml, per
tutto il tratto, cioè, in cui attraversa zone urbanizzate.
Nel corso del secondo dopoguerra
si procede anche alla modifica delle sponde della Valletta in prossimità di
viale Oriani con l’attivazione di una discarica di inerti; questo progressivo
riempimento determina alla fine del ‘900 un ulteriore restringimento della
Valletta con la formazione a livello di viale Oriani di un’area pianeggiante
sulla quale è stato realizzato un parcheggio pubblico.
Nel 1969 la S.A. Fonderie
Officine di Gorizia che occupa i terreni situati in prossimità della confluenza
del torrente con l’Isonzo, redige un apposito progetto di copertura del tratto
del Corno da viale Colombo alle sponde dell’Isonzo suddiviso in quattro lotti.
Di tale progetto sono stati realizzati tre lotti da viale Colombo al piazzale
di entrata nello stabilimento industriale.
In questa località l’ultimo
tratto del torrente era già stato deviato nei primi decenni del 900 in seguito
alla realizzazione degli impianti industriali nell’ultimo settore della
Valletta, successivamente alla costruzione del viale Colombo. Tale intervento
aveva spostato il punto di confluenza nell’Isonzo di circa 400 ml più a valle,
creando una continuità edilizia lungo la sponda del fiume ed occupando con gli
stabilimenti industriali il tratto terminale della Valletta.
Nel corso dei secoli passati
quando il torrente Corno correva ancora in un ambito extraurbano e lambiva i
borghi esterni alla città vera e propria, sulla sommità delle sponde della Valletta,
sono state costruite diverse ville appartenenti a famiglie nobili circondate da
ampi parchi.
Si tratta della villa Coronini di viale XX Settembre
che nella seconda metà dell’ 800 estende il proprio parco, strutturato sul
modello del Parco di Miramare, sul versante della Valletta fra il rilevato
della strada del Ponte Nuovo ed il Borgo Piazzutta. Un meandro del torrente,
ormai interrato, segna ancora
l’andamento orografico del parco.
Sull’altro lato della nuova
strada, nel 1862 il Barone Formentini
iniziò ad edificare sul terreno acquistato dalla famiglia Coronini, una grande
villa il cui parco si estendeva lungo la
sponda destra del torrente, arrivando fino all’alveo; già alla fine del secolo
venne trasformata in albergo e all’inizio del 900, prima dello scoppio della
guerra, in sede per il Ginnasio.
Successivamente il parco venne
frazionato ed oggi si presenta occupato in parte da impianti sportivi ed in
parte dall’area di pertinenza dell’edificio scolastico.
Più a valle, anche il parco
della Villa Luisa (casa padronale
costruita all fine del secolo XVIII in testa al grande viale dello Studeniz,
oggi via Diaz), si estende sulla sponda sinistra, della Valletta, giungendo
quasi fino alla località dove esisteva un antico guado sul torrente.
Infine in prossimità della
confluenza del Corno nell’Isonzo sulla sommità della sponda destra del
torrente, alla fine del secolo XIX ad opera dei proprietari degli stabilimenti
produttivi costruiti sulla sponda del fiume, è sorta la Villa Ritter, circondata da un ampio parco che si estende in parte
anche sul versante ripido della scarpata. Oggi la villa di proprietà pubblica,
destinata ad ospitare attività universitarie, è in fase di restauro.
Nel tratto iniziale del corso
del torrente, anche se non così chiaramente legata come negli altri casi alla
presenza del corso d’acqua e della Valletta, sorge la villa Baguer (Palazzo
Catterini, il cui parco si estendeva fino alla sponda destra del torrente e
lungo il percorso che la costeggiava (attuale via Catterini). Lungo tutta la
sponda sinistra del torrente in quest’ultimo tratto del suo corso, nel sec. XIX
gli appezzamenti di terreno che si affacciano sul corso d’acqua facevano parte
del vivaio Seiller, che probabilmente utilizzava le acque del torrente per
l’irrigazione; successivamente il grande appezzamento di terreno venne
frazionato in due settori dalla strada che portava al nuovo camposanto (attuale
via San Gabriele), lungo la quale negli anni successivi vennero costruiti vari
edifici.
Anche in tempi più recenti, in seguito
all’estendersi dell’urbanizzazione a sud-ovest del centro più antico, ed in
particolare lungo la via Leopardi sulla Valletta si affacciarono diverse ville,
fra le quali la villa Sussi, che
estende il suo parco lungo il versante della Valletta fino al torrente ed anche
oltre sulla sponda destra.
Si ricorda che il piano di
ricostruzione della città del 1921 prevedeva, in tutta la Valletta, la
realizzazione di un grande parco pubblico, con percorsi nel verde e due
piazzali , uno nel fondo valle a metà del tratto tra viale XX Settembre e viale
Oriani, e l’altro in prossimità di viale Colombo; su quest’ultimo si doveva
affacciare, in base al disegno urbanistico, in alto sulla sponda destra, un
edificio pubblico.
Per alcuni dei parchi ora
menzionati esiste ancora oggi continuità con le aree inedificate della
Valletta; in particolare per la villa Sussi e per la parte del suo parco
strutturata a bosco.
In conclusione si può rilevare
come nel corso degli ultimi 150 anni, nonostante la presenza dei parchi storici
sopra ricordati, la situazione di fatto lungo il corso del torrente si sia
radicalmente modificata, con una progressiva trasformazione da ambiente
naturale ad ambiente urbano anche se non edificato, caratterizzato, però, da
opere di canalizzazione dell’acqua e di modifica dell’assetto geomorfologico
delle sponde.

Figura 6: vecchie protezioni spondali in
pietra, presenti all’interno del parco lungo il Corno, a valle del terrapieno
di viale Oriani.
Lo strumento urbanistico della città di Gorizia
Lo strumento di pianificazione
paesaggistica, urbanistica e territoriale di riferimento operante nel contesto
paesaggistico nell’area interessata dagli interventi risulta essere il PRGC di
Gorizia di cui si riportano di seguito gli allegati di riferimento. Non
risultano essere presenti altri strumenti di pianificazione vigenti.
Il corso del torrente Corno, interessato dal
progetto
passa interamente in ambito urbano (settore nord-ovest della città). Si può
suddividere in tre tratti:
1) tratto dal confine di Stato
all’ingresso nel parco urbano della Valletta;
2) tratto di attraversamento
della Valletta fino al viale Colombo;
3) tratto da viale Colombo fino
alla confluenza nell’ Isonzo.
Nel primo tratto il corso è completamente
interrato, il secondo tratto corre quasi interamente a cielo aperto, con
esclusione dei tratti di attraversamento di sedi stradali (viale Oriani, strade
pedonali interne alla Valletta), nel terzo tratto passa in parte interrato
all’interno del lotto di uno stabilimento industriale, in parte a cielo aperto
prima della confluenza nell’ Isonzo.
Si evidenziano i seguenti
elementi riguardanti il Corno e le aree adiacenti il suo corso:
-Valle del Corno
-Parchi e giardini storici
-Edifici di valore storico ed
ambientale
-Viali alberati storici
-Sponde naturali dell’Isonzo
Il P.R.G.C. attribuisca un
notevole valore dal punto di vista storico e ambientale a quelle parti della
città che vengono attraversate dal corso d’acqua, sia per la presenza di
elementi caratteristici dal punto di vista geomorfologico e naturalistico
(Valletta del Corno), sia per la vicinanza di componenti delle formazioni
insediative più antiche (ville con parco - Centro Storico).
Il parco della Valletta
rappresenta in ogni caso l’elemento caratterizzante le previsioni del P.R.G.C.
in tutta la fascia dell’ambito urbano attraversato dal corso del torrente
Corno.
Ai fini urbanistici è importante
la continuità delle aree destinate al verde ed al tempo libero esistenti sia
nella Valletta che nelle vicinanze, la facile accessibilità dagli altri parchi
storici adiacenti (Parco Coronini, Parco di Villa Luisa, giardini pubblici di
Corso Verdi) e la vicinanza alle zone centrali della città ed agli insediamenti
abitativi; è importante inoltre l’esistenza nelle adiacenze di aree riservate a
parcheggi pubblici (parcheggio di viale Oriani).
Lo strumento di riferimento per
l’analisi della conformità urbanistica dei manufatti in progetto, è il Piano
Regolatore Generale del Comune di Gorizia.
Di seguito si riportano alcuni
estratti dal PRGC vigente del Comune di Gorizia e le relative considerazioni.
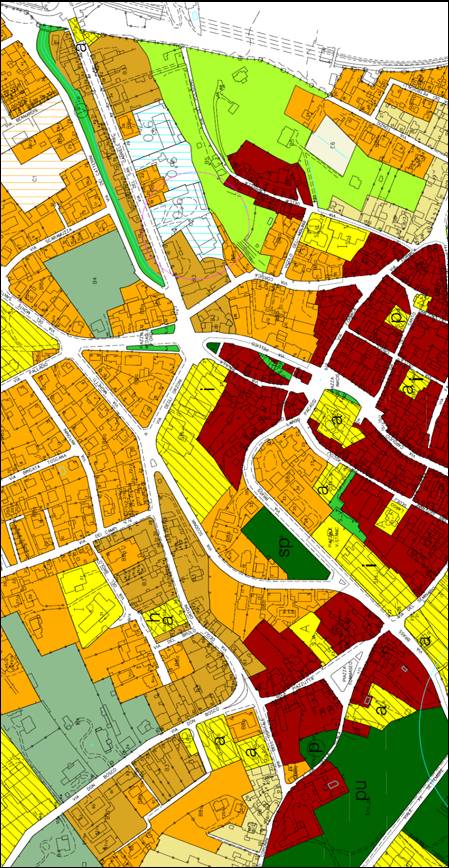
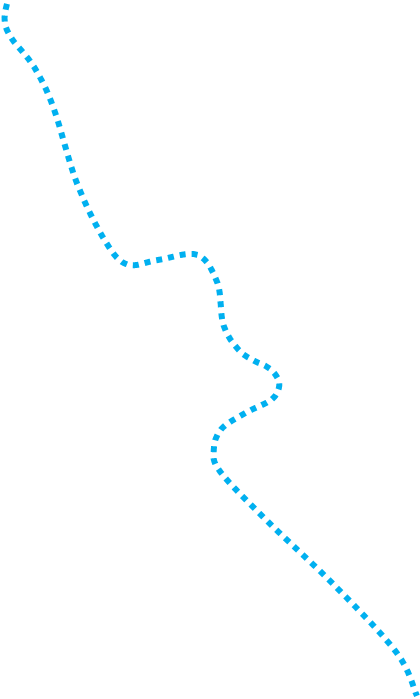 Figura 11: Comune di Gorizia Variante al
PRGC n.35 – Azzonamento.
Figura 11: Comune di Gorizia Variante al
PRGC n.35 – Azzonamento.
Tratto del T. Corno coperto dal
confine di Stato al viale XX Settembre (linea tratteggiata azzurra).
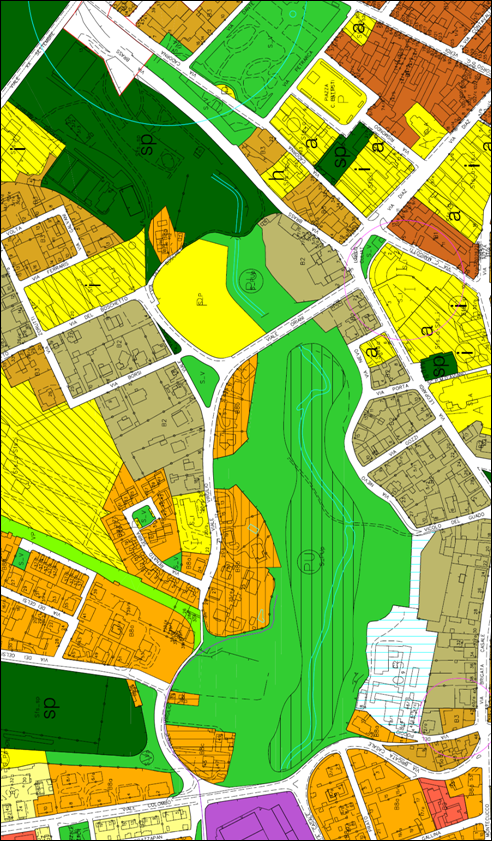
Figura 12: Comune di Gorizia Variante al
PRGC n.35 – Azzonamento TAV. 2
Tratto del T. Corno dal viale XX
Settembr al viale C. Colombo.
![]()
![]()

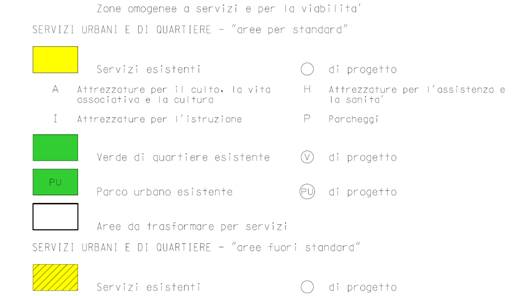
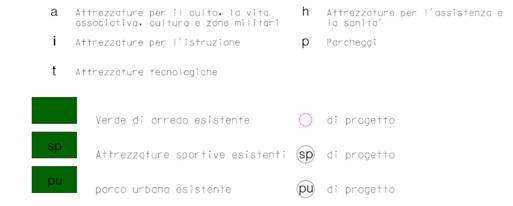
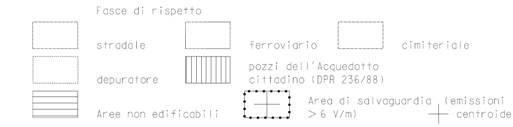
Il parco della Valletta rappresenta l’elemento caratterizzante le previsioni del P.R.G.C. in tutta la fascia dell’ambito urbano attraversato dal corso del torrente Corno.
Si suddivide in due settori che sostanzialmente sono destinati a svolgere funzioni complementari:
- Zona “sp”: attrezzature sportive esistenti dal viale XX Settembre a via del Boschetto
- Zona “PU”: Parco urbano di progetto da via del Boschetto al viale C. Colombo.
La zona a verde sportiva risulta
funzionalmente connesso con il verde comprendente il giardino pubblico di Corso
Verdi mediante i percorsi pedonali che attraversano le aree verdi lungo le
scarpate che collegano
Ai fini urbanistici risulta assai importante la continuità delle aree destinate a verde ed al tempo libero esistenti sia nella Valletta che nelle vicinanze, la facile accessibilità degli altri parchi storici adiacenti (Parco Cornini, Parco di Villa Luisa, giardini pubblici di Corso Verdi) e la vicinanza alle zone centrali della città ed agli insediamenti abitativi; è importante inoltre l’esistenza nelle immediate vicinanze di aree riservate a parcheggi pubblici (parcheggio di viale Oriani).
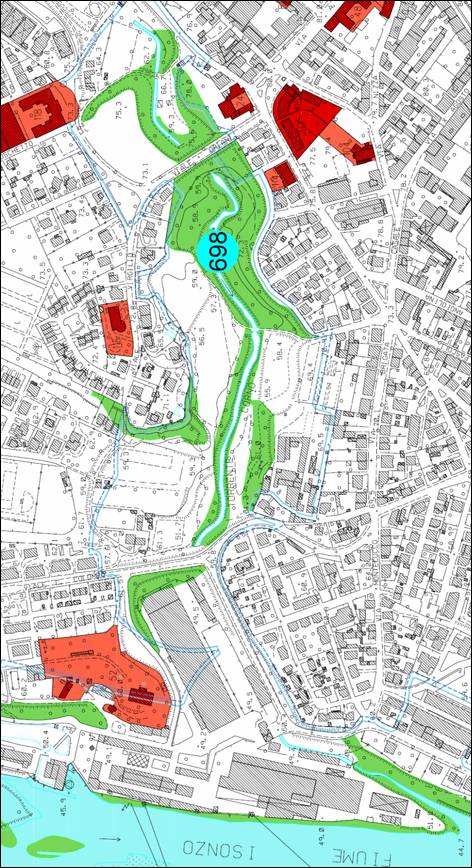
figura 13: vincoli e fasce di rispetto – valletta
PRGC - Norme tecniche
di attuazione – 29 dicembre 2011 variante n.35
Di seguito si
riportano gli articoli 42 e 44 del PRGC di Gorizia, rispettivamente “Norme di
tutela ambientale” e “Fasce di rispetto e vincoli”.
Art. 42 Norme di tutela ambientale
1 Le norme del presente articolo si applicano su tutto il territorio
comunale e riguardano:
2 a) Modifiche dell’assetto del suolo
Tutti gli interventi che comportano modifiche all’assetto del suolo quali
sbancamenti, asportazione dello strato di coltura, formazione di strade o
piazzali anche se in semplice massicciata, ecc. e tutti gli interventi aventi
rilevanza urbanistica ed urbanistico-ambientale (vedi art.6, punti 2 e 3)
devono essere verificati sulla scorta della Relazione di sintesi e norme di
attuazione di carattere geologico allegata al Piano ed applicare le
prescrizioni ivi contenute.
2bis Negli interventi di nuova edificazione o di sistemazione dei terreni
è vietato procedere alla colmatura di scoline, fossetti di guardia e di scolo e
in generale alterare il normale deflusso delle acque superficiali verso i
ricettori esistenti.
3 Nelle aree individuate come “Colli urbani” nella tavola del “Patrimonio
della città” tutti gli interventi devono essere finalizzati a non alterare
l’immagine dell’ambiente e del paesaggio. Particolari cautele devono essere
assunte in relazione alle caratteristiche costruttive degli edifici e dei
materiali da costruzione, che devono rispettare quelli della tradizione locale
così come esplicitati nell’Allegato 1 “Individuazione delle caratteristiche
edilizie e delle tecniche costruttive” relative alla zona A Città antica e Castello.
4 Nella fascia collinare le recinzioni delle proprietà, sia su fronte
stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, devono essere formate
con siepi vive di altezza non superiore a m. 2 con interposta eventuale rete
metallica plastificata oppure con cancellata, con zoccolatura limitata (minore
o uguale a cm. 80), provvista di idonei scoli per le acque.
5 E’ consentito il mantenimento degli esistenti muri di cinta a parete
piena, che possono essere oggetto di parziali rifacimenti quando le condizioni
statiche del manufatto lo rendano indispensabile.
6 Nell’Ambito paesaggistico ambientale così come individuato nella tavola
P.1.1 nuovi muri di sostegno, quando necessari, sono ammessi, anche di accesso
alle autorimesse interrate, con un’altezza massima di m. 2. I nuovi muri di
sostegno da realizzare all’interno delle zone E2 e E4 devono essere realizzati
prioritariamente con tecniche dell’ingegneria naturalistica.
7 Nei casi in cui sia necessaria una maggiore altezza, essi devono essere
spezzati in gradoni di larghezza non inferiore a m. 2 opportunamente mascherati
da arbusti e alberature.
8 E’ consentito il mantenimento degli esistenti muri di sostegno, anche di
maggiore altezza, che possono essere oggetto di rifacimenti parziali con materiali
e tecniche congruenti alle caratteristiche tipologiche esistenti e proprie
della tradizione dei luoghi, quando le condizioni statiche del manufatto lo
rendano indispensabile; anche in tal caso le caratteristiche tecniche sono
definite dal progetto esecutivo dell’opera che deve rispettare le condizioni
e/o prescrizioni della normativa geologica.
9 In tutto il territorio comunale, in caso di realizzazione di autorimesse
interrate pubbliche o private o di altri servizi pubblici nel sottosuolo, il
progetto deve prevedere la sistemazione del soprassuolo destinato a servizi
secondo le destinazioni di piano. In particolare nelle aree che il piano
destina a verde pubblico la realizzazione di parcheggi in sottosuolo è ammessa
e deve garantire un riporto di terra non inferiore a m.1,50 sufficiente alla
realizzazione del verde e delle alberature.
In tali aree deve comunque essere garantita una quota minima pari al 60%
per la realizzazione del verde in piena terra (non su soletta).
9 bis Nelle zone residenziali sono ammesse costruzioni in sottosuolo e le
relative rampe di accesso; non sono ammessi nuovi spazi esterni scoperti al di
sotto della quota media del terreno.
9 ter In tutte le aree libere da costruzioni, sistemate a verde sono
ammesse costruzioni in sottosuolo destinate ad autorimesse purché ricoperte da
uno strato di terreno atto alla formazione del verde di spessore non inferiore
a cm. 70. E’ altresì consentita la costruzione di piscine scoperte di
dimensioni tali da non alterare l’immagine complessiva del verde in relazione
all’edificato. La costruzione di autorimesse e piscine è subordinata al
rispetto delle essenze arboree preesistenti se di pregio.
L'altezza complessiva emergente dal livello marciapiede stradale o dal
terreno naturale circostante non deve essere superiore a m. 1,50.
10 b) Tutela delle alberature e del verde in genere E’ vietato utilizzare
aree a bosco o a prato per depositi di ogni genere di materiale.
11 In tutti i progetti presentati le alberature d’alto fusto esistenti
devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie ed anche, se
richiesto, documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti
in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali alberature,
nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo cura di non offendere gli
apparati radicali.
Qualora si rendesse necessario l’abbattimento di piante costituenti i
viali alberati storici - in caso di morte, malattia e pericolo per la pubblica
incolumità, anche a causa di lavori di sistemazione delle sedi stradali, e
delle relative infrastrutture, che comportino il taglio di parte dell’apparato
radicale - dovrà essere valutata, caso per caso, con il competente Servizio del
Verde Pubblico, la sostituzione delle piante, la specie, la dimensione e la
distanza alla quale i nuovi esemplari dovranno essere posti, affinché venga
mantenuto il viale alberato storico.
12 Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato
della sistemazione degli spazi aperti, e quindi anche delle aree alberate, a
prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo e
la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati,
delle zone pavimentate.
13 c) Corsi d’acqua
Tutti i nuovi interventi sui corsi d’acqua iscritti negli elenchi del RD
11.12.1933 n.1775, dirette ad interventire sulle sponde, sull’argine e
sull’alveo degli stessi sono sottoposti alle procedure del D.Lgs. 42/2004,
parte terza.
14 Nella fascia di rispetto dei 150 m., nelle zone in cui si applica la
legge 431/85, tutti gli interventi lungo le sponde naturali dell’Isonzo e delle
acque pubbliche presenti nel territorio comunale devono essere finalizzati alla
rinaturalizzazione dei luoghi e delle sponde. E’ consentita la creazione di
percorsi pedonali e ciclabili. Tali interventi devono essere realizzati con
tecniche di ingegneria naturalistica. E’ vietato l’uso di materiali cementizi.
In particolare lungo tutti i corsi d’acqua pubblici nella fascia di rispetto
dei 30 m (nelle zone in cui applica il D.Lgs.42/2004, parte terza ) nelle zone
E4 adiacenti all’A.R.I.A. e nelle sottozone d/E6 comprese nell’A.R.I.A.,
indicate con apposito simbolo nella tav. P.9 è vietata ogni nuova costruzione.
Sugli edifici esistenti ricadenti in tale fascia sono consentiti unicamente
interventi di manutenzione e risanamento conservativo. Nelle successive fasce
edificabili gli interventi devono essere valutati in relazione alle tipologie e
altezze edilizie, tali da non costituire impatto negativo nei confronti del corso
d’acqua tutelato e del suo contesto.
15 d) Riduzione della impermeabilizzazione
I nuovi spazi pubblici e le aree di pertinenza per interventi di nuova
realizzazione e ristrutturazione urbanistica devono essere realizzati con
modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o ritenzione anche
temporanea delle acque. Tuttavia per motivi di sicurezza quali le esigenze
statiche in relazione a carichi stradali particolarmente gravosi e in rapporto
alle caratteristiche geotecniche dei terreni, in relazione ad esigenze di
prevenzione della contaminazione del suolo da sversamenti di sostanze
inquinanti, è possibile procedere alla messa in opera di coperture del suolo
impermeabili.
Art. 44 Fasce di rispetto e vincoli
1 Il Prg individua le fasce di rispetto ed i vincoli nella
tavola “Vincoli e fasce di rispetto” in scala 1:5.000.
2 Le aree ricadenti in fasce di rispetto assumono l'indice
di edificabilità delle Zone omogenee in cui ricadono che può essere utilizzato
al di fuori dell’area vincolata secondo i parametri e le procedure della zona
stessa. Entro le fasce di rispetto vigono le prescrizioni delle leggi di
settore richiamate nella tavola “Vincoli e fasce di rispetto”, i parametri
edilizi ed urbanistici della zona omogenea di appartenenza e, là dove presenti,
le prescrizioni dell’allegato B alle presenti norme denominato “Relazione di
sintesi e norme di attuazione di carattere geologico”. Sugli edifici compresi
nelle fasce di rispetto sono ammessi gli interventi di cui all’art. 41 comma 3
L.R. 52/91 s.m.i.
3 Stralciato con Variante n.10
Le ampiezze dimensionali delle fasce di rispetto
cimiteriali, indicate nella tavola P.2 “Azzonamento, sono così determinate:
- Cimitero centrale: 200 ml ad esclusione della fascia nord
ridotta a 100 ml (Delibera del Comitato di gestione dell’U.S.L. n. 2 d.d.
17/02/1987);
- Cimiteri di S.Andrea, Piedimonte, Lucinico, Piuma e
S.Mauro: 100 ml (Ordinanza Direttore Generale A.S.S. n.2 Isontina dd.
29.9.1997)
4 Nelle fasce di rispetto stradale sono consentite le
seguenti opere:
- ampliamento degli edifici esistenti fino ad un massimo di
50 mq Slp, previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada, per
interventi di miglioramento igienico-sanitario, purchè realizzato in
sopraelevazione o sulla parte restrostante l’edificio rispetto all’asse viario.
- impianti di distribuzione di carburante con le relative
opere accessorie nel rispetto delle norme del Piano di programmazione e
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (DPGR 16.12.2002
n.0394/Pres);
- pensiline di ingresso di edifici ed a protezione di aree
a parcheggio;
- recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità;
- nell’interrato: cabine elettriche e relativi volumi
tecnici.
Le ampiezze dimensionali delle fasce di rispetto stradali,
indicate nella tavola P.2 “Azzonamento” (delimitate ai sensi del Piano
regionale della viabilità) sono così determinate:
- viabilità autostradale (raccordo autostradale
Gorizia-Villesse): 60 ml
- viabilità di grande comunicazione (S.S 56 bis esistente e
di previsione e SS 55): 40 ml
- viabilità di interesse regionale (Mainizza): 30 ml
- viabilità locale: 20 ml (10 ml all’interno
dell’ambito della Comunità montana del Collio)
5 Nella tavola P.2 “Azzonamento” sono indicati i perimetri
delle aree e i corsi d’acqua gravati da problematiche di carattere geologico ed
idraulico, definiti “aree non edificabili”, quali:
- aree esondabili di pertinenza del fiume Isonzo;
- aree esondabili del torrente Corno e torrente Groina
presso la confluenza del fiume Isonzo, e aree di pertinenza del torrente
Piumizza;
- aree di competenza dei corsi d’acqua minori;
- aree di terrazzo alluvionale che delimitano il corso del
fiume Isonzo, comprese le scarpate;
- aree con depositi di materiali inerti.
5_bis L’attuazione dell’Area Strategica 8, è subordinata
al rispetto delle prescrizioni contenute al punto 8 della Relazione Geologica
allegata alla Variante n. 34 al Piano Regolatore Generale Comunale.
6 Nella tavola P.2 “Azzonamento” è indicato il perimetro
dell’area di pertinenza dei pozzi dell’acquedotto cittadino.
Entro tale zona è consentita unicamente la possibilità di
realizzare un nuovo edificio, da destinare a uffici amministrativi, nel
rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:
- Slp max edificio: 2000 mq;
- Superficie complessiva dell’intervento comprensiva degli
edifici esistenti e delle pertinenze mq: 7800 mq;
- H max: 9.00 mt;
L’intervento è anche subordinato al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
- l’edificio dovrà essere sviluppato a est del fabbricato
esistente, entro una fascia di larghezza max 90 mt dal ciglio stradale,
parallela alla SS 351 - “Stradone della Mainizza”
- le acque nere dovranno essere convogliate in una nuova
condotta fognaria ed allontanate dall’area;
- la nuova condotta fognaria dovrà connettersi alla rete
esistente posta lungo lo stradone della Mainizza, con un nuovo braccio sulla
medesima sede stradale;
- le acque meteoriche provenienti dai tetti degli edifici e
dai piazzali (ivi compresi i parcheggi) devono essere raccolte in una vasca di
prima pioggia e successivamente smaltite secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia;
- le aree parcheggi ed i piazzali dovranno essere
localizzati entro una fascia parallela alla SS 351 - “Stradone della Mainizza”,
di larghezza max 90 mt dal ciglio stradale e dovranno essere pavimentati e
dotati di impianto disoleatore.
Restano ferme le prescrizioni di cui all’art.94 comma 4 del
Dlgs 16 gennaio 2008, n.4.
7 Le aree interessate da progetti di bonifica sono individuate nella
tavola “A.3 -Vincoli e fasce di rispetto”.
Entro dette aree qualsiasi intervento edilizio e/o cambio di destinazione
d’uso, dovrà essere preceduto dalla modifica del progetto di bonifica già
approvato.
PRGC: Relazione “Rappresentazione schematica delle
strategie del Piano” 29 dicembre 2011 – variante n.35
Premessa
La presente relazione costituisce documento illustrativo e di supporto
alla tavola “Rappresentazione schematica delle strategie del Piano”, nonché
documento propedeutico alle definizioni e ai contenuti, laddove richiamati,
della Relazione sui limiti di flessibilità di PRGC.
Tale documento costituisce risposta a quella parte delle riserve regionali
riportate al punto conclusivo A. Aspetto processuale.
Al fine di poter rispondere in modo esaustivo ed articolato alle riserve
regionali, che richiedono di “completare, integrare, esplicitare, dar conto,
....” in modo sistematico alla “Rappresentazione schematica delle strategie del
Piano” con specifico riferimento agli obiettivi, agli elementi strutturali,
alle strategie, all’interno del territorio comunale sono stati riconosciuti gli
ambiti, così come sotto elencati, e per ognuno di questi precisati gli
obiettivi strategici, le invarianti, gli elementi strutturali, le strategie, i
limiti di flessibilità, le salvaguardie.
Si forniscono di seguito, per una corretta lettura dei contenuti della
presente relazione, le seguenti definizioni:
Definizioni
Ambiti territoriali e funzionali
Parti del territorio comunale individuate sulla base delle conoscenze
relative all’ambiente, alla storia, alla cultura, ai caratteri insediativi e
delle attività presenti o previste sul territorio. All’interno di ciascun
ambito sono precisati gli elementi strutturali, gli obiettivi strategici, le
strategie operative, le invarianti di tutela ambientale, i limiti di
flessibilità, le salvaguardie.
Gli ambiti costituiscono elementi di riferimento al fine di individuare,
alla luce dei disposti della L.R. 52/’91, le invarianti, gli elementi
strutturali e i limiti di flessibilità del Piano.
All’interno del territorio comunale sono stati individuati i seguenti
ambiti territoriali e funzionali:
1. Ambito paesaggistico-ambientale
2. Ambito insediativo
3. Ambito delle attività
4. Ambito confinario
5. Ambito infrastrutturale
6. Grandi servizi
7. Ambito agricolo Nord – Est
8. Ambito agricolo Sud – Ovest
….
Ambiti territoriali e funzionali
Ambito paesaggistico-ambientale
1. Definizione degli elementi strutturali
L’ambito paesaggistico-ambientale costituisce una risorsa di rilevanza
territoriale per la quale il Piano intende avviare un’azione di tutela, di
salvaguardia e di valorizzazione dei valori ambientali, storici e
paesaggistici. Esso comprende le aree boschive e agricolo-produttive del Collio
e le aree del Monte Sabotino, il sistema dei colli urbani e il “Parco del
Castello e del Re”, le sponde naturali dell’Isonzo, la valle del Torrente Corno
e le aree ricomprese all’interno della zona di trasformazione strategica n.2
(unità di intervento 2a). L’unità di intervento 2a è finalizzata alla
riqualificazione delle sponde dell’Isonzo e alla connessione dello stesso con
il parco del torrente Corno.
Sono elementi strutturali dell’ambito paesaggistico-ambientale:
- Patrimonio ambientale (Sponde naturali dell’Isonzo, Colli Urbani e Valle
del torrente Corno)
- Patrimonio storico (edifici nell’ambito, siti archeologici)
- Patrimonio culturale (testimonianze dei sistemi militari, difensivi e
tracce della Grande Guerra)
2. Obiettivi strategici
Sono obiettivi strategici del Piano all’interno dell’ambito ambientale:
- Tutela del Patrimonio ambientale, storico, culturale al fine di
tramandare i valori testimoniali dei manufatti e il loro rapporto con
l’ambiente circostante
- Valorizzazione paesistica con specifico riferimento alla salvaguardia
del patrimonio boschivo in relazione al miglioramento dell’assetto
vegetazionale, quali elementi di stabilizzazione di aree potenzialmente franose
o interessate da fenomeni erosivi
- Valorizzazione produttiva del Collio finalizzata alla prosecuzione delle
attività agricole e vitivinicole in atto, nel rispetto dell’orografia e
dell’equilibrio idrogeologico del terreno
- Valorizzazione della conoscenza e fruizione del territorio attraverso
l’incremento della mobilità pedonale e ciclabile - Riqualificazione delle
sponde dell’Isonzo e del torrente Corno al fine di ricreare una continuità
paesaggistica e di fruizione ambientale del fiume
- Tutela dei territori di preminente interesse agricolo
- Valorizzazione del Parco del Castello e del Re
3. Strategie operative
Ripristino e consolidamento delle aree boscate e sistemazione
idraulico-forestale dei corsi d’acqua e dei pendii in frana.
Disciplina analitico-progettuale degli interventi sugli edifici e delle
tecniche costruttive al fine di tramandare l’immagine dell’edificato
costituente elemento fondativi del paesaggio.
Attuazione del Parco e del Percorso del Castello e del Re contestualmente
all’entrata in Europa della Slovenia.
Disciplina delle trasformazioni all’interno dell’unità di intervento 2a
attraverso una successiva variante preordinata alla realizzazione di aree
pubbliche destinate all’insediamento di attività sportive e per il tempo libero
legate alla fruizione del fiume Isonzo.
Realizzazione dei seguenti percorsi:
- percorso delle tracce della Grande Guerra
- percorsi naturali dell’Isonzo e del Collio
- percorso della Riconciliazione
- Percorso del Castello e del Re
Sistemazione e riqualificazione delle sponde naturali dell’Isonzo e del
torrente Corno.
Disciplina degli interventi all’interno delle zone agricole e di
preminente interesse agricolo nonché tutela delle culture viticole del Collio
4. Elementi strutturali - inviarianti di natura ambientale
- Aree esondabili
- Instabilità dei terreni
5. Limiti di flessibilità del Piano
Livello 1d per la realizzazione dei percorsi territoriali, secondo livello
per la Zona di trasformazione strategica n.2, unità di intervento 2a, indicata
nella carta delle “Rappresentazione schematica delle strategie del piano” come
facente parte dell’ambito paesaggistico-ambientale nonché del Parco e del
Percorso del Castello e del Re e terzo livello nel caso vengano modificate le
invarianti di natura ambientale e gli elementi strutturali esclusivamente per
motivi di pubblica sicurezza o di pubblico interesse da parte degli Enti
pubblici a tal fine preposti.
La variante dovrà farsi carico di disciplinare gli interventi ammissibili
per l’ambito 2° tenendo come riferimento la scheda normativa allegata al
presente Piano struttura.
6. Salvaguardie
Gli interventi ammessi secondo le disposizioni contenute nel piano
operativo, all’interno della zona di trasformazione strategica n.2 (unità di
intervento 2a), in attesa della trasformazione prevista nella tavola delle
“Rappresentazione schematica delle strategie del Piano”, non devono precludere
la possibilità di realizzare, da parte dell’Amministrazione comunale, un
collegamento tra il parco del torrente Corno e le sponde del fiume Isonzo.
Rilievo con localizzazione delle emergenze architettoniche, quali edifici, manufatti o infrastrutture relative al corso d’acqua con eventuale integrazione della documentazione fotografica
Tutte le murature in
pietra esistenti, verranno mantenute e sistemate senza modificarne le
caratteristiche tipologiche e dei materiali.
Per quanto concerne la
riqualificazione del tratto lungo via dei Catterini, essa è stata ampiamente
affrontata nei punti precedenti, valorizzandone gli aspetti ambientali e la
fruibilità. In tale tratto le emergenze architettoniche di limitatissima
valenza, vengono ad essere preservate ed integrate.
Da questo punto fino a raggiungere
il parco della Valletta, l’intervento non prevede alcuna modificazione
all’esistente, trovandosi il torrente Corno completamente interrato
nell’ambiente urbano.
Di seguito quindi, si riportano
il rilievo delle emergenze architettoniche relative al corso d’acqua nel tratto
della Valletta, oggetto di riqualificazione.
Le fotografie rappresentano in
sequenza il corso del torrente Corno, da monte a valle, dal parco pubblico di
Via Italico Brass al Viale C.Colombo.
Per i punti di ripresa fotografica VEDERE
L’ALLEGATO A) IN FONDO ALLA RELAZIONE.
non si rilevano altre emergenze
architettoniche a valle del guado fino all’ingresso sotto viale c. colombo.
eventuali ritrovamenti di vecchi muretti in pietra ormai andati distrutti e
nascosti dalla folta vegetazione verranno ripristinati secondo le antiche
tradizioni, caratteristiche costruttive e dei materiali.

FOTO 1 - parco pubblico di via
Italico Brass: emerge vistosamente il limite spondale tracciato dal torrente
Corno, attualmente interrato e posto sulla destra dello stesso nell’immagine
sopra. Si tratta di un muretto dell’altezza di circa 60 cm in pietra locale che
un tempo rappresentava la sponda del torrente.

FOTO 2 - particolare del muretto
che delimita il torrente Corno coperto. La pietra è locale, tipo carsica o
arenacea marnosa. Il progetto non prevede alcun cambiamento dello stato
attuale.

FOTO 3 - Inizio del tratto
scoperto del torrente Corno: particolare dello sbocco. Si nota in primo piano
la vecchia protezione in calcestruzzo e tubolari in acciaio che delimita il
tratto tombato.

FOTO 4 - la scarpata di via
Italico Brass lungo il torrente Corno. Essa è sostenuta da un muro di sostegno
in pietra locale (forse un tempo limite spondale del torrente Corno).
Successivamente è stata realizzata la protezione in calcestruzzo del fondo e
delle sponde del Corno visibili in primo piano nell’immagine soprastante. Il
progetto prevede la sistemazione e il consolidamento al piede del muro di
sostegno preservandone le caratteristiche e la realizzazione della protezione
del fondo e delle sponde mediante un canale rivestito in pietra squadrata
perfettamente integrato con le murature esistenti. Questa protezione del fondo
risulta necessaria per garantire la stabilità delle importanti strutture
limitrofe, come meglio esposto ai punti successivi.
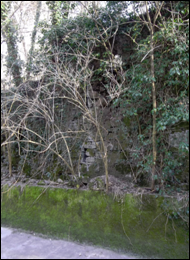
FOTO 5 - particolare del muro di
sostegno di cui sopra addossato alla protezione spondale in calcestruzzo
esistente.

FOTO 6 - vista frontale del muro
di sostegno con al di sotto la protezione spondale in calcestruzzo.

FOTO 7 - particolare del muro di
sostegno in pietra locale.

FOTO 8 - sponda del torrente
Corno e muro di sostegno in pietra locale faccia a vista

FOTO 9 - lavori della Protezione
Civile Regionale nell’anno 2009. Tali lavori hanno evidenziato l’esistenza in
diversi tratti di una vecchia protezione del fondo in pietra.

FOTO 10 - muro di protezione
spondale in prossimità del vecchio ponte in pietra di via del Boschetto. Il
progetto prevede la manutenzione di queste emergenze architettoniche e la realizzazione
di tutti i manufatti in progetto con la stessa tipologia di pietra e la
medesima “texture”, al fine dell’ottimale inserimento paesaggistico.

FOTO 11 - muro di contenimento
della scarpata di via Italico Brass in pietra, a monte del vecchio ponte di via
del Boschetto.

FOTO 12 - il vecchio ponte in
pietra di via del Boschetto ripreso da valle.

FOTO 13 - il vecchio ponte in
pietra di via del Boschetto ripreso da monte.

FOTO 14 - particolare del muro
di sostegno in pietra lungo le spalle del vecchio ponte.

FOTO 15 - Via del Boschetto
sopra il vecchio ponte. Si nota l’emergenza della vecchia struttura del ponte
ad arco. Il progetto prevede la risistemazione del sedime preservandone le
caratteristiche.
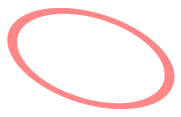

FOTO 16 - lavori della
Protezione Civile Regionale anno 2009, tratto subito a valle di Viale Oriani.
Al piede della nuova tubazione, in particolare lungo la sponda destra, si nota
la presenza di un rivestimento del fondo in blocchi di pietra a testimonianza
che prima della cementificazione superficiale dell’alveo, esisteva già un
rivestimento del fondo in diversi tratti del torrente Corno.
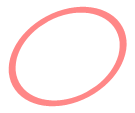

FOTO 17 - particolare di un
vecchio muro in pietra di protezione spondale subito a valle del terrapieno di
Viale Oriani. Foto ripresa da monte verso valle, sponda sinistra.
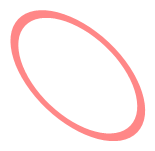

FOTO 18 - vecchio muro in pietra
di protezione spondale subito a valle del terrapieno di Viale Oriani. Foto
ripresa da valle verso monte, sponda sinistra.
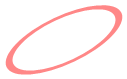

FOTO 19 - muretto di protezione
spondale a valle del terrapieno di Viale Oriani. Lunghezza della protezione
circa 10 metri. Particolare vedi vista fontale sotto.

FOTO 20 - particolare (vista
frontale) del muretto in pietra di protezione spondale di cui sopra.
L’intervento ne prevede il mantenimento e la sua sistemazione.

FOTO 21 - guado di Via del Guado
interamente in calcestruzzo e tubazioni in cls prefabbricato per il passaggio
dell’acqua. L’intervento consiste nella sostituzione dell’elemento mal inserito
nel contesto paesaggistico del Corno, con un nuovo ponte carrabile realizzato
con materiali tradizionali quali la pietra e il legno in totale armonia con il
territorio e le caratteristiche delle emergenze architettoniche presenti.

FOTO 22 - particolare di un
vecchio scolo delle acque meteoriche in blocchi di pietra in prossimità del
guado di cui sopra. Il progetto ne prevede il mantenimento e sistemazione.

FOTO 23 - muro di sostegno per
il terrapieno del Viale Cristoforo Colombo

FOTO 24 - muro di sostegno in
pietra squadrata avente una altezza di 2,5m presso il terrapieno di viale
Colombo

FOTO 25 - muro di sostegno in
pietra squadrata avente una altezza di 2,5m presso il terrapieno di viale
Colombo
Interventi sulla vegetazione, rilievo con schede di dettaglio dei livelli di degrado e qualità paesaggistica con le tecniche d’intervento previste per ogni sito
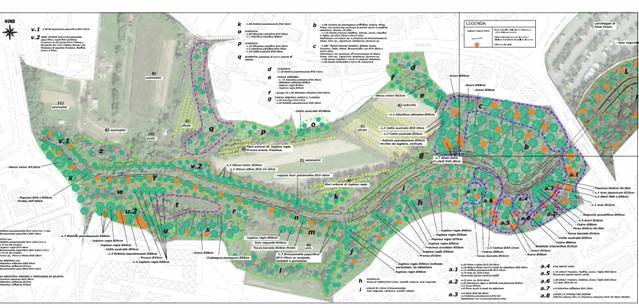
Figura 21: tavole del rilievo
arboreo-arbustivo del parco della Valletta

Figura 37: il Corno coperto a fianco di
Via dei Catterini. La foto è scattata dall’incrocio con via S.Gabriele.

Figura 38: il parco urbano lungo via
Brass. Il perimetro della staccionata evidenzia il percorso del torrente Corno
che scorre al di sotto.
Gli interventi più consistenti
di trasformazione paesaggistica del corso del torrente si realizzarono nel
secondo dopoguerra, quando, con la costruzione della via Italico Brass, tutto
il tratto del corso d’acqua dal confine di Stato alla Valletta viene incanalato
e tombato. Il progetto predisposto dall’ Uffcio Tecnico del Comune di Gorizia,
porta la data del 8 febbraio 1950.
Nel 1964 il Comune di Gorizia
predispone un’ulteriore progetto di copertura del torrente Corno nella Valletta
per l’ampliamento del giardino pubblico. In seguito alla realizzazione di
questo intervento il corso del torrente risulta coperto per circa 1700 ml, per
tutto il tratto, cioè, in cui attraversa zone urbanizzate.

Figura 39: il torrente Corno canalizzato
all’inizio del tratto a cielo aperto nel parco della Valletta.

Figura 40: tratto di torrente Corno
canalizzato. In lontananza il terrapieno di Viale Oriani.

Figura 41: il torrente Corno a valle del
terrapieno di Viale Oriani. In sponda sinistra si nota l’intervento, realizzato
dalla Protezione Civile nel 2010, che raccoglie le acque fognarie all’interno
di una tubazione e le rilascia, come si vede dalla foto, poco più a valle del
terrapieno di viale Oriani.

Figura 42: visibili cedimenti lungo la
sponda sinistra a valle del terrapieno di Viale Oriani.
Anche in tempi più recenti, in
seguito all’estendersi dell’urbanizzazione a sud-ovest del centro più antico,
ed in particolare lungo la via Leopardi sulla Valletta si affacciarono diverse
ville , fra le quali la villa Sussi, che estende il suo parco lungo il versante
della Valletta fino al torrente ed anche oltre sulla sponda destra.
Si ricorda che il piano di
ricostruzione della città del 1921 prevedeva, in tutta la Valletta, la realizzazione
di un grande parco pubblico, con percorsi nel verde e due piazzali , uno nel
fondo valle a metà del tratto tra viale XX Settembre e viale Oriani, e l’altro
in prossimità di viale Colombo.
Per alcuni dei parchi ora
menzionati esiste ancora oggi continuità con le aree inedificate della
Valletta; in particolare per la villa Sussi
e per la parte del suo parco strutturata a bosco.

Figura 43: vicolo del guado con l’attuale
manufatto di attraversamento del Corno.

Figura 44: Viale Oriani.

Figura 45: situazione della vegetazione
lungo la pista esistente scendendo da Via Ippolito Nievo.

Figura 46: villa Coronini ripresa dal
Largo Culiat

Figura 47: campo coltivato in prossimità
del vicolo del Guado.

Figura 48: seminativi esistenti
all’interno del parco.

Figura 49: presenza di piante schiantate
e gravemente instabili all’interno del parco della Valletta in sponda sinistra
del torrente Corno, a valle del terrapieno di viale Oriani.
Riqualificazione igienico-sanitaria e paesagggistico-ambientale
Ad oggi nel Corno vengono
riversate tal quali le fognature nere della città di Nova Gorica, con
conseguenze di danno sia al Corno stesso sia al ricettore fiume Isonzo. Il
liquame una volta superato il tratto coperto del Corno, interessa l’area della
Valletta con decadimento delle qualità ecologico-ambientali ed igienico-sanitarie.
Già la Protezione Civile della Regione, conscia della situazione, ha effettuato
nel 2009 un intervento di emergenza cercando di intubare per un breve tratto la
portata nera di magra del Corno. Tale intervento però è riuscito solo
marginalmente a dare soluzione al problema in quanto la possibilità di
intasamento della tubazione posata all’interno dell’alveo e la limitata
lunghezza del tratto sistemato, non sono in grado di conferire una adeguata
sistemazione igienica del torrente Corno. Gli interventi previsti in Slovenia
dovranno comunque risolvere il problema, mediante la realizzazione del nuovo
depuratore a Vrtojba (con recapito finale nel
fiume Vipacco)
eliminando completamente l’attuale scarico nel Corno. Rimangono comunque
presenti sul territorio i danni ambientali dovuti allo stato attuale delle cose
e dal suo essersi protratto per lungo tempo. Il mancato intervento
determinerebbe quindi il perdurare di una situazione sanitariamente e
ambientalmente insostenibile in un’area urbana quale la Città di Gorizia e per
di più in un’area dalla spiccata valenza paesaggistico-ambientale quale risulta
essere quella della Valletta del torrente Corno e, più a valle, del Fiume
Isonzo.
Risultati attesi dall’attuazione del progetto
Con
le opere in progetto ci si propone di raggiungere i seguenti risultati:
-la messa in sicurezza idraulica
dell’abitato di Gorizia nei confronti di possibili esondazioni del Corno
provenienti dal territorio Sloveno;
-il risanamento igienico del
torrente mediante l’eliminazione degli apporti di acque nere sia in territorio
Sloveno che Italiano, grazie a:
- da parte dell’Amministrazione
Slovena con la realizzazione del depuratore delle acque reflue dell’abitato di
Nova Gorica (opera già progettata e prossima all’appalto da realizzarsi in
Comune di Vrtojba con recapito finale nel fiume Vipacco);
- in territorio italiano con il
risanamento e rifacimento delle condotte della fognatura nera che si sviluppano
lungo il torrente Corno e sono collegate alla rete del depuratore di Gorizia.
-la riqualificazione
naturalistico-ambientale del parco della Valletta nel cuore della città con
indubbi vantaggi per la qualità dell’ambiente e con la riqualificazione dal
punto di vista paesistico di un settore urbano oggi trascurato ed inutilizzato;
-la conseguente eliminazione
delle emissioni maleodoranti attualmente percepibili nelle vicinanze dei tratti
aperti del torrente, con indubbio miglioramento della qualità della vita per i
residenti in un ampio settore della città.
L’area denominata Valletta è il punto in cui il torrente Corno acquisisce le maggiori valenze paesaggistico-ambientali del suo intero percorso. Queste risultano attualmente depauperate a causa della tipologia e qualità delle acque che percorrono il sedime fluviale, di provenienza fognaria. A seguito della realizzazione del sistema di depurazione di Nuova Gorica questa problematica verrà ad essere eliminata, consentendo la riqualificazione completa del Corno e del suo alveo, restituendo alla città di Gorizia un corso d’acqua vivibile.
Dal punto di vista della sistemazione idraulica il presente progetto prevede per l’area della Valletta la suddivisione in due differenti ambiti, rispettivamente a monte e a valle del rilevato di viale Oriani, rilevato che suddivide in due parti di dimensioni simili l’area.
Partendo da monte, subito a valle del tratto tombato esistente del torrente Corno, nel punto in cui lo stesso diviene a cielo aperto, è prevista la realizzazione del manufatto di sbocco della condotta microtunnelling di progetto. Le acque dei due condotti (torrente Corno tombato e microtunnelling) si uniscono in questo punto, procedendo poi congiunte verso valle, in direzione dell’Isonzo. Il manufatto è interrato per buona parte del suo percorso, in modo da occultare visivamente la tubazione.
Dallo sbocco di cui sopra fino immediatamente a valle del rilevato di viale Oriani l’alveo del Corno si presenta attualmente imbrigliato, con fondo e pareti in calcestruzzo in evidente stato di ammaloramento. Il progetto prevede di demolire l’esistente canale, realizzandone uno nuovo in pietra locale di elevato spessore (30 cm al fine della massima durabilità) andando a modificare sia l’andamento della livelletta sia la quota dello scorrimento. Infatti si prevede di eliminare i piccoli salti di fondo ora presenti lungo la tratta, andando a realizzare un’unica pendenza per il tratto, maggiore dell’esistente ed in grado di allontanare al meglio la portata di progetto.

Figura
52: sezione
tipo della sistemazione del torrente Corno nel tratto canalizzato fino a viale
Oriani.
Unicamente al disotto di viale Oriani, dove l’alveo del Corno sottopassa l’arteria stradale mediante un manufatto di circa 55m di lunghezza, a volta circolare, non si effettuerà alcuna modifica della pendenza in quanto la stessa risulta essere già analoga a quella di progetto prevista. Lungo tutto il tratto canalizzato invece si prevede di apportare un abbassamento dell’alveo del Corno di circa 40cm.
Ciò comporta un deciso aumento della capacità di deflusso della sezione del torrente, consentendo alla portata di piena di attraversare in sicurezza l’area. Questo è importante soprattutto al disotto di viale Oriani dove, la limitata dimensione dell’attraversamento esistente, determina un innalzamento del tirante a monte. L’abbassamento del fondo alveo consente di ridurre questo fenomeno, determinando al massimo dei limitati allagamenti delle aree limitrofe al canale del tutto compatibili con la destinazione d’uso delle aree (parco urbano) e con gli elevati tempi di ritorno di progetto.
Immediatamente a valle dell’asse di viale Oriani, l’alveo del torrente Corno diviene naturale, con andamento fortemente discontinuo soprattutto per quanto concerne le sponde esistenti le quali manifestano ampie erosioni ed accumuli di materiali. Ciò comporta un andamento irregolare della portata di piena con conseguente aumento della vorticosità e della capacità erosiva, innescando un pericoloso incremento del fenomeno di decadimento delle sponde. A queste problematiche il presente progetto risponde in modo compiuto, andando ad effettuare una ricalibratura della livelletta, assegnando una pendenza continua leggermente inferiore di quella del tratto canalizzato posto più a monte. Le attuali sponde maggiormente esposte alle erosioni vengono ad essere sistemate mediante una protezione spondale in ciottoli e sassi, eliminando tutti i materiali che possono determinare pericolose ostruzioni alle acque di piena e realizzando uno spazio golenale verde di circa 3,5m sul lato destro del fiume. Lungo il piede delle sponde, su entrambi i lati, viene ad essere realizzata una piccola protezione in sassi in modo da impedire l’erosione localizzata (v. paragrafo 1.2).
Motivazioni del rifacimento del tratto di torrente Corno con alveo e sponde in pietra locale (arenaria) a valle del parco pubblico fino viale Oriani
Guardando lo stato di fatto, in corrispondenza del parco pubblico di via Italico Brass, dove il torrente Corno si presenta interrato, si riscontra la presenza del vecchio muro spondale realizzato in blocchi di pietra squadrata a testimonianza di una preesistenza architettonica da rivalorizzare del tutto simile a quanto previsto in progetto per il tratto scoperto immediatamente a valle.
Nel tratto a cielo aperto subito a valle del parco esistente, lungo la sinistra alveo è presente una muratura di sostegno sempre realizzata in pietra squadrata, di caratteristiche estetiche analoghe a quello precedente, avente il duplice scopo di sostenere il rilevato sul quale si trova il sedime stradale di via Italico Brass e di protezione spondale del corso del Corno antecedente l’intervento di cementificazione del fondo.
La pendenza dell’alveo del Corno è tale da poter determinare durante gli eventi di piena velocità dell’acqua tali da poter innescare fenomeni erosivi al fondo e sulle sponde. Prova ne è la realizzazione anni fa del rivestimento in c.a. e la presenza di numerosi salti di fondo aventi lo scopo di ridurre la stessa. Tale pendenza si riduce a valle dell’attraversamento di Viale Oriani.
La presenza di manufatti in prossimità dell’alveo impone la necessità di una impermeabilizzazione del fondo in quanto la filtrazione delle acque nei terreni al di sotto dei manufatti stessi può portare a fenomeni di instabilizzazione delle fondazioni con conseguente pericolo di crollo degli stessi. Questo risulta tanto vero se si considera il pericolo di erosione spondale durante gli eventi di piena. Si ricorda infatti che a valle del parco pubblico di via Italico Brass, il muro di pietra squadrata sostiene il piede del rilevato stradale. Inoltre questi manufatti hanno una valenza architettonica e pertanto devono essere protetti.
In considerazione di quanto sopra, l’intervento progettuale prevede il rispetto delle emergenze architettoniche esistenti (muri in pietra, vecchio ponte) attraverso il ripristino di tutte le strutture murarie del sito e l’integrazione di un rivestimento del torrente Corno in armonia con le preesistenze.
Il tratto a valle del parco attuale fino a viale Oriani risulta essere stato nel corso del tempo sempre oggetto di protezioni spondali e dell’alveo, essendo presenti lungo le sponde del corso d’acqua importanti rilevati artificiali (rilevato stradale di via Italico Brass, vecchio ponte di Via del Boschetto, rilevato del parcheggio in sponda destra, rilevato del parco storico di villa Coronini e rilevato di viale Oriani). Ciò ha comportato la realizzazione di diversi manufatti che attualmente collaborano alla stabilità dei rilevati.
Le sezioni del Corno verranno realizzate come da progetto in pietra locale (calcare grigio): gli angoli lungo le sponde nella parte in basso sono addolciti e la sezione dell’alveo non rimane costante in modo da permettere il “divagare” o “zigzagare” della magra lungo il tratto (v. la planimetria sotto con il corso del Corno in magra. Inoltre la creazione di alcune “pozze” leggermente più profonde rende questo tratto più vicino al naturale e migliora la funzionalità biologico-ambientale del corso. Si realizzeranno poi due punti di accesso all’alveo ubicati in modo ottimale in prossimità del ponte di Via del Boschetto. In questo modo si rende possibile agli utenti del parco l’accesso e la fruibilità del torrente. Le pozze saranno realizzate proprio in corrispondenza di questi accessi.

Figura 53: planimetria di progetto del tratto di torrente Corno tra il parco pubblico e il terrapieno di Viale Oriani. Al centro si vede l’attraversamento di Via del Boschetto. Si notano i due punti di contatto e di accesso all’alveo proprio in corrispondenza del vecchio ponte in pietra.

Figura 54
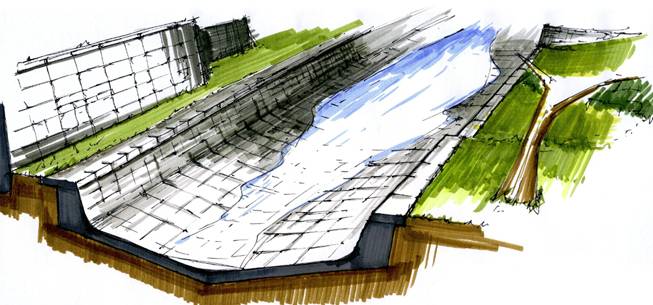
Figura
55: viste
prospettiche e planimetriche del corso del torrente Corno in magra, così come
previsto dal progetto: come si vede l’alveo di magra scorre in modo
“naturale”, divagando nel letto a destra e a sinistra. Verranno inoltre create
alcune pozze più profonde per migliorare le caratteristiche idrobiologiche. Si
prevede inoltre di realizzare alcuni accessi al torrente in prossimità del
ponte di via del Boschetto per rendere maggiormente fruibile il corso d’acqua e
creare un’interazione uomo-acqua.

Figura 56: schema di progetto del divagare del torrente Corno nel tratto con alveo e sponde in pietra locale. Grazie alla sezione “non costante” dell’alveo rivestito in pietra e alla creazione di alcune pozze più profonde, si è cercato di dare una certa naturalità allo scorrere dell’acqua del Corno.

Figura 57: STATO DI FATTO dell’alveo e delle sponde cementificate.

Figura 58: FOTOSIMULAZIONE del rivestimento del fondo in pietra e delle sponde con muretti sempre in pietra della stessa tipologia di quelli esistenti. Torrente Corno in magra.

Figura 59: STATO DI FATTO del vecchio ponte in pietra di via del Boschetto all’interno della Valletta.

Figura 60: FOTOSIMULAZIONE. Torrente Corno in piena.
Torrente Corno a valle del terrapieno di viale Oriani: protezioni spondali in pietra nei tratti esposti alle erosioni
Osservando lo stato attuale
dell’alveo, la tessitura del pietrame sedimentato lungo il suo corso e le
manifestazioni erosive in particolari tratti nonché la vegetazione in stato di
abbandono lungo le sponde, il progetto mira a proteggere tratti di sponda in
erosione del torrente Corno al fine di preservarne le caratteristiche nel
tempo.
Lungo i tratti esposti alle erosioni del torrente
Corno (v. tav. 3.5.1) la scelta è rivolta ad intervenire con una protezione al
piede spondale che utilizza pietre di diversa pezzatura locali legate al fondo
fra loro con un parziale utilizzo di legante cementizio che non viene reso
percepibile tra le fughe. Lungo le sponde invece si opterà per una protezione
sempre in sassi e pietre locali non cementati al fine di conferire un aspetto
naturale dell’intera sponda (v. tav. particolari 3.5.2).
La scelta risulta adeguata sia da un punto di vista
statico, riducendo i fenomeni erosivi, sia attenta all’attuale condizione del
sedime che già presenta analoghe contingenze quali conglomerati naturali
(visibili da rilievo in situ, tratti dove si presentano ciottoli legati fra
loro dal calcare di deposito), in modo molto simile a quanto previsto in
progetto.
L’attenuazione del declivio dei
bordi del corso dell’acqua e il mantenimento di un verde raso lungo il tratto,
eviterà lo sviluppo di formazioni vegetali invasive, che ne depauperano lo
stato negando l’accessibilità all’uomo e costringendo la municipalità a
frequenti interventi manutentivi. A questo proposito si vuole far notare come
recenti risultati di interventi con talee e fascinate vive, hanno dimostrato il
manifestarsi di uno sviluppo vegetazionale incontrollato che spesso va a determinare
l’inaccessibilità dei luoghi ed un inaccettabile impedimento al deflusso delle
acque di piena. Al contrario quanto previsto in progetto, con la presenza di
ciottoli sul bordo spondale si garantisce lo sviluppo di essenze erbacee lungo
gli interstizi tra sasso e sasso riempiti nella parte sommitale di terreno e
allo stesso tempo impedisce lo sviluppo di infestanti arbustive, a vantaggio
del verde a raso idoneo a garantire una maggiore qualità visiva (e di accesso)
del torrente Corno.
L’assenza di vegetazione
spontanea non controllata porta beneficio alle essenze arbustive autoctone del
sito che domineranno così la cornice verde delle sponde, valorizzando il
contesto.
Seguendo un percorso progettuale
difensivo nei riguardi del letto del torrente, si prevengono erosioni che
indebolirebbero la situazione vegetativa e destabilizzerebbero la sicurezza
delle sponde.
Un esempio efficace che
riportiamo, relativo alla protezione spondale mediante sassi e ciottoli valide
per i tratti maggiormente esposti alle erosioni a valle di Viale Oriani, è
quello realizzato lungo il fiume Isar in pieno centro città a Monaco di
Baviera: sebbene la scala del fiume sia maggiore, il concetto è quello di
mantenere la naturalità delle sponde con una protezione in sassi compatibile
con la funzionalità del fiume che si integra perfettamente e crea una unione
“corso d’acqua-uomo” indicata in ambienti urbani. In questa sistemazione, che
attualmente viene spesso riportata ad esempio in recenti convegni di
sistemazione fluviale e rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, si è proceduto a
rinaturalizzare un tratto del fiume Isar che presentava eccessive
geometrizzazioni unite a notevoli erosioni spondali nei punti non protetti. La
soluzione adottata con la realizzazione di punti di perturbazione localizzata
dell’acqua favorenti l’ossigenazione (realizzati mediante soglie in massi) e la
piccola protezione spondale in sassi per l’alveo di magra, ha fornito risultati
estremamente incoraggianti sia da un punto di vista della rinaturalizzazione sia
da quello della nuova fruizione del fiume da parte della cittadinanza. Questi
sono i motivi che hanno ispirato le scelte progettuali, ricercando di
pervenire, benché su scala minore, a risultati similari a quelli ottenuti in
Germania.
Ulteriori esempi di sistemazioni
spondali in sassi locali sono visibili di seguito e riguardano la sistemazione
effettuata dallo studio Causero nel 2007 lungo il Rio del Lago di Fusine (Laghi
di Fusine) e lo stesso fiume Isonzo a Salcano (SLO). Tale sistemazione è simile
a quella che proponiamo nel tratto di t.Corno in oggetto, sul principio di
creare piccole “step and pool” (pozze) e delle protezioni in sassi laterali
perfettamente inserite nel contesto ambientale.

Figura 61: tratto a valle del guado
esistente. L’intervento consiste solamente per alcuni tratti oggetto di
erosioni spondali in una protezione in sassi delle sponde. Si notino sulle
sponde la presenza di ciottoli e ghiaie che caratterizzano tutto il corso del
Corno a valle di Viale Oriani. Lungo tale tratto si rilevano inoltre numerosi
affioramenti di strati conglomeratici dovuti alla sedimentazione di calcare.

Figura 62: situazione dell’alveo e delle
sponde a valle del guado. L’intervento prevede anche la manutenzione arborea e
arbustiva presente pericolosamente lungo le sponde (piante scalzate,
inclinate). Si notino in destra gli affioramenti conglomeratici naturali.

Figura 63: esempio di sistemazione
spondale lungo il fiume Isar a Monaco di Baviera.


Figura 64: sistemazione spondale e
step-pool in lungo il Rio del Lago a
Fusine – intervento realizzato dalla Studio Causero nell’anno 2007.

Figura 65: sistemazione spondale e step-pool
in lungo il Rio del Lago a Fusine –
intervento realizzato dalla Studio Causero nell’anno 2007.

Figura 66: sistemazione spondale in sassi
e pietre lungo il fiume Isonzo a Salcano.

Figura 67: sistemazione spondale in sassi
e pietre lungo il fiume Isonzo a Salcano.
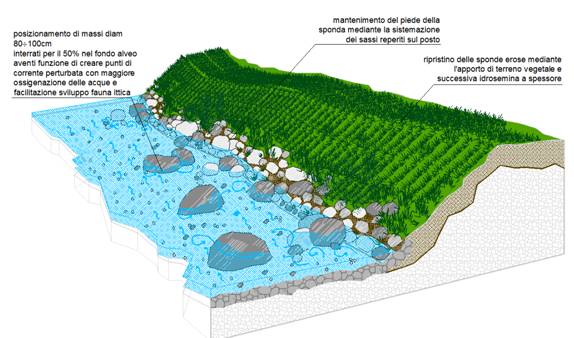
Figura 68: intervento di progetto della
protezione spondale in sassi lungo i tratti maggiormente esposti alle erosioni.
L’attuale configurazione della
rete fognaria di Gorizia, del tipo misto, prevede una serie di sfioratori di
troppo pieno che, solamente durante gli eventi meteorici di una certa
intensità, scaricano le portate in eccesso rispetto alle capacità della rete di
fognatura nera all’interno dell’attuale alveo del Corno in via dei Catterini.
Queste portate, benché sufficientemente diluite per quanto concerne il grado di
concentrazione di inquinanti fognari, risultano comunque poter trasportare in
sospensione particelle sporche che possono depositarsi lungo tale tratto. Per
questo motivo la soluzione progettuale prevede di trasportare le acque pulite
del Corno lungo la nuova condotta microtunneling bypassando il tratto di via dei
Catterini, nel quale si avrà portata defluente esclusivamente durante i
fenomeni meteorici più intensi che determinano l’azionamento degli sfioratori
fognari.
Pertanto le scelte progettuali
mirano al mantenimento, durante i tempi di asciutta, della massima qualità
delle acque del Corno impedendone la contaminazione che si potrebbe avere
facendole defluire lungo l’attuale percorso di via dei Catterini. In questo
modo la qualità delle acque che poi percorrono la Valletta è garantita. Durante
gli eventi meteorici intensi invece le acque percorrono entrambi i condotti,
per poi riunirsi a monte della Valletta e, ulteriormente diluite, attraversare
il tratto a cielo aperto.
Ne consegue che lungo via dei
Catterini si ha portata defluente esclusivamente durante gli eventi meteorici
di una certa intensità, mentre per tutto il resto del tempo risulta in
asciutta.
Per queste motivazioni una
riapertura del tratto di via dei Catterini non risulta più essere la soluzione
ottimale in quanto la rarità del deflusso e la possibilità che vi siano locali
depositi di materiali fini provenienti dagli sfiori fognari ne sconsigliano
l’attuazione.
Le scelte adottate quindi per
l’attuale versione del progetto della sistemazione del torrente Corno, lungo
via dei Catterini, hanno quale obbiettivo la riqualificazione del sito
portandolo ad un reintegro della sua funzione
pubblica. L’attuale degrado del tratto, che per necessità igieniche e di
vicinanza all’abitato risulta coperto ormai da molti anni, ha richiesto
un’attenta soluzione in grado di fornire da una parte la fruibilità del sito al
pubblico sia di quartiere sia esterno e dall’altra la valorizzazione dei valori
storici e di memoria che il percorso acqueo deteneva in rapporto al tessuto
urbano cittadino e che attualmente risultano del tutto smarriti.
Gli interventi consistono nel
rifacimento dell’attuale copertura del Corno non sufficientemente stabile. Si
prevede la stesa di uno spessore di circa 50 cm di terreno vegetale e la
realizzazione di una superficie a prato e di una pista ciclopedonale.
La “via” di progetto che si
andrà a realizzare vuole quindi evidenziare il percorso del torrente, tenendo
conto dello stretto contatto con le strutture abitative (addossate con i muri
di recinzione e/o le murature stesse lungo tutto il fianco sinistro)
integrandosi ed interagendo con esse, puntando a divenire un luogo di
percorrenza e di verde ad uso pubblico.
Si prevede pertanto la
realizzazione di una “fascia” continua dove il manto erboso verde viene
affiancato da un percorso pedonale, con l’alternanza di aiuole piantumate ad
arbusti e servizi per il pubblico quali panchine e apparecchi illuminanti, ne
scandiscono il ritmo.
Se da una parte il mantenimento
della copertura del corso d’acqua lungo il tratto in oggetto è necessario,
visto il considerevole impatto che la sua riapertura comporterebbe nei riguardi
dell’intorno abitato (accessibilità negata, condizioni igieniche non sempre
garantite, impatto dimensionale dato dal volume del cavo acqueo addossato sui
bordi dei perimetri privati), dall’altra la soluzione progettuale dialoga con
il pubblico invitandolo a “camminare” lungo il Corno così da percepirne la
natura e raccontarne la storia. La nuova via viene resa accessibile da una
rampa principale in testa al percorso in prossimità del confine italo-sloveno e
da una successione di rampe di scale lungo il declivio che la congiunge con via
dei Catterini.
obbiettivi dell’intervento
L’intervento mira a
riqualificare il tratto del torrente Corno interrato lungo via dei Catterini
prevedendo:
-
il mantenimento e sistemazione della copertura del corso d’acqua (la
scelta, come detto, è imputata a ragioni igieniche e di impatto ambientale con
il confinante bordo residenziale). Il mantenimento dell’attuale caratteristica
pedonale e l’inserimento di un mirato arredo urbano porta a risultati di
progetto cui l’obbiettivo è creare una maggiore fruibilità e permeabilità fra
lo spazio pubblico e quello privato delle residenze;
-
il miglioramento dell’accessibilità al sito, posto ad una quota
inferiore rispetto al piano stradale delle vie limitrofe, disponendo due
ingressi principali alle estremità del tratto di corso e intervenendo, lungo il
percorso, con accessi per mezzo di scale lungo via dei Catterini.
La soluzione prevede il
rinverdimento del tratto coperto del torrente Corno, la realizzazione di una
pista ciclo-pedonale in pietrisco stabilizzato con alcuni inserti in ghiaia ai
piedi della scarpata di Via dei Catterini, la collocazione di idonei arredi
urbani come panchine in calcestruzzo rivestito in legno trattato e di appositi
impianti di illuminazione con una alternanza di piantumazioni di piccoli
alberelli di Lagerstroemia indica a scandirne la successione e, nel lato
opposto, la creazione di un “bordo-verde” collocato lungo il confine
dell’edificato al fine di creare un gradevole prospetto su entrambi i fronti,
sia per il pubblico che frequenta tale tratto sia per il privato residente.
Le piante utilizzate in
quest’ultima “fascia mitigatrice” riguardano essenze principalmente arbustive,
idonee per il loro portamento, colore e fioritura ad essere inserite nei
contesti urbani ma anche richiamanti la flora autoctona presente nell’ambiente
naturale intorno a Gorizia. Le specie utilizzate sono:
-
Laurus nobilis
-
Cotinus coggygria
-
Viburnum opulus
-
Cornus alba in varietà
Oltre a richiamare le essenze
autoctone presenti nel territorio, vengono inserite nel contesto per la loro
varietà in forma e dimensione in altezza con l’obiettivo di creare delle
suggestioni che richiamino il movimento e lo scorrere dell’acqua del torrente
Corno. Inoltre grazie alla loro rusticità e al loro portamento abbastanza
contenuto, queste piante non necessitano di periodici e frequenti interventi di
manutenzione, limitando così nel tempo le spese per la loro gestione e cura.

Figura 69: sezione tipo e pianta

Figura 70: vista prospettica del tratto
di torrente Corno coperto lungo Via dei Catterini

Figura 71: prospetto

Figura 72: lo stato di fatto

Figura 73: fotosimulazione del progetto –
tratto di t. Corno coperto a fianco di via del Catterini.
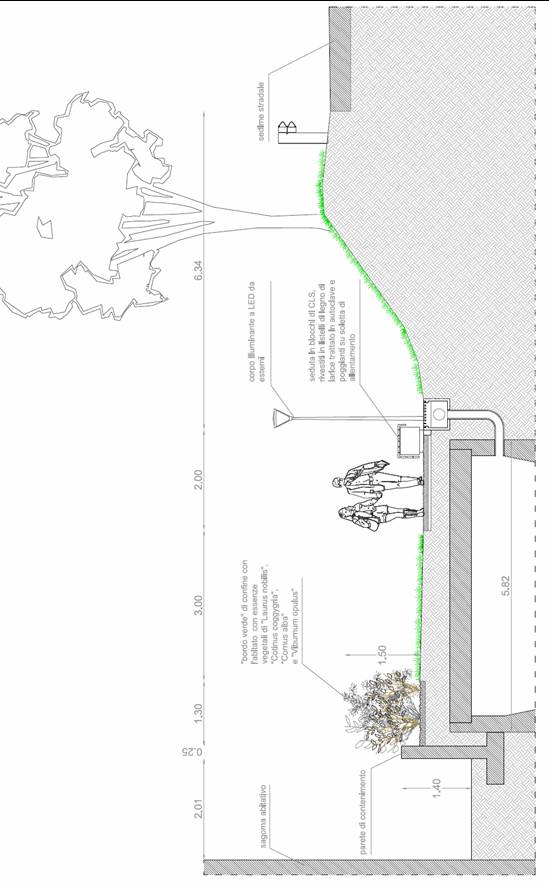
Figura 74: sezione tecnica tipo
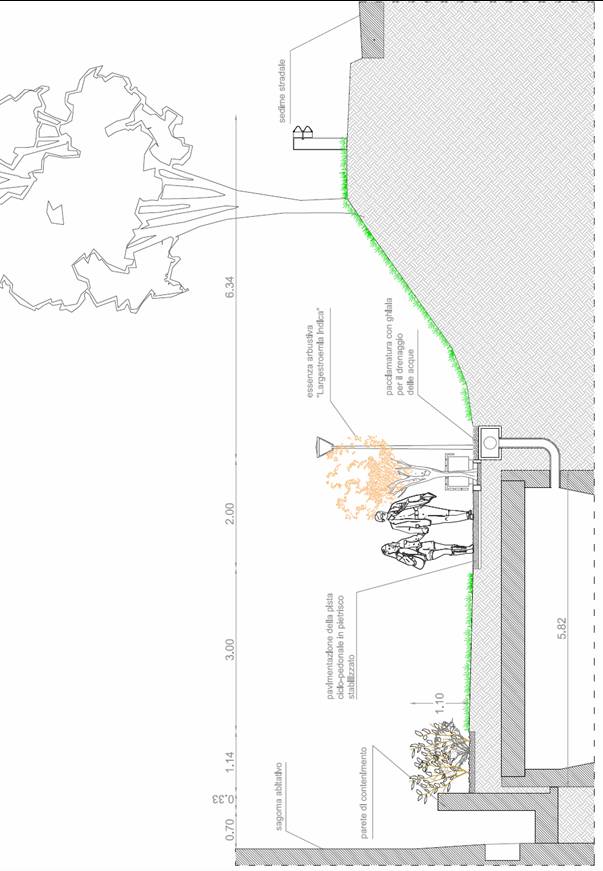
Figura 75: sezione tecnica tipo lungo il
tratto con la presenza del fabbricato residenziale più vicino al Corno
Come riportato al punto
precedente esistono valide motivazioni che determinano la scelta di non riportare
alla luce l’alveo del torrente Corno in prossimità di via dei Catterini.
Per quanto concerne l’intervento
previsto in corrispondenza dell’incrocio con la via San Gabriele, si è
provveduto a formulare una soluzione progettuale che consente una migliore
identificazione del corso d’acqua, un suo richiamo e la valorizzazione di un
punto del sedime attualmente degradato.
A tale scopo, all’estremo
opposto del corso verde-pedonale di cui al punto precedente, in corrispondenza
del ponte di attraversamento di via S. Gabriele, si prevede un intervento
capace di mettere in relazione il tratto a pavimento terminale del percorso e
la riqualificazione di seguito descritta della parete verticale al di sotto del
ponte. Il richiamo all’acqua e quindi al torrente Corno viene ottenuto mediante
una soluzione che ne sottolinea la presenza: uno specchio d’acqua verticale a
scandire la superficie, alimentato da una cascata a getto continuo a ricircolo.
obbiettivi dell’intervento
La sistemazione della parete
sotto il ponte di attraversamento stradale in prossimità dell’ incrocio fra via
dei Catterini e via San Gabriele. Viene creata una parete verticale d’acqua (a
mascheramento dell’attuale piano verticale tamponante il cavo del sottoponte),
alimentata da un impianto idraulico a getto continuo che genera un getto a
cascata uniforme lungo un tratto della parete. Le parti di pareti limitrofe
alla cascata d’acqua daranno spazio, rispettivamente, ad un pannello
informativo (in corrispondenza della risalita di scale) in acciaio Corten in cui verranno riportati i
riferimenti storico-geografici del torrente e, per il tratto limitrofe al
confine di proprietà privata, ad essenze vegetali rampicanti.
Per consentire l’ispezione per
la manutenzione del torrente Corno verrà predisposto, dietro la cascata
d’acqua, una apertura a scorrimento in acciaio architettonicamente uniforme al
contesto.
La realizzazione di uno spazio
fruibile dalla popolazione, riqualificato, illuminato e dotato di punti di
sosta con numerosi accessi in comunicazione con via dei Catterini.

Figura 76: STATO DI FATTO
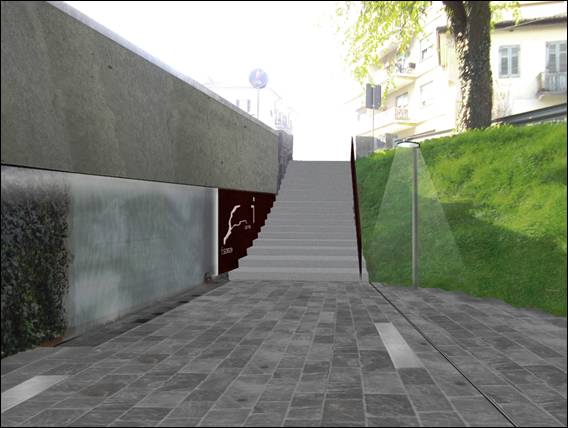
Figura 77: FOTOSIMULAZIONE con la
percezione del corso d’acqua mediante la realizzazione di fontana “a cascata”
in corrispondenza dell’incrocio di via San Gabriele
Parte
integrante del progetto è la sistemazione della Valletta del Corno.
Per
Valletta del Corno si deve intendere quell’insieme di aree verdi a diversa
connotazione, attualmente articolate, da monte a valle, nei seguenti settori:
- da via XX Settembre a via
del Boschetto: Giardino Pubblico di
proprietà comunale con prevalente funzione sportiva e ricreativa, di informazione e
intrattenimento;
- da via del Boschetto al
terrapieno di viale Antonio Oriani: area verde rurale e
contigua area boscata con limitrofe scarpate, ristretta area a causa
dell’ampio parcheggio di viale Oriani. Area in stato di abbandono naturale, da
evidenziare per il limitrofo parco della villa Coronini in sponda sinistra;
- dal viale Antonio Oriani
al viale Cristoforo Colombo: in sponda destra vasta
aera verde a prevalente connotazione rurale e in sponda sinistra in
corrispondenza della discesa verso il guado presenza di aree coltivate ad orto.
Lungo le sponde presenza di una folta e a tratti impenetrabile vegetazione
arboreo-arbustiva ricca di specie sinantropiche.
La
valletta del Corno è un’incisione valliva in substrati conglomeratici di Alta
Pianura. Il fondo di tale incisione è costituito dalle alluvioni depositate dal
torrente Corno.
Le
scarpate di terrazzamento fluviale che cingono la Valletta, caratterizzate da
substrato conglomeratico e da notevole acclività sono in generale improntate ad
una certa secchezza ambientale anche se l’esposizione, la copertura,
l’acclività e il carattere torrentizio del torrente Corno favoriscono il
mantenimento di una certa umidità in diversi periodi dell’anno, soprattutto
lungo l’alveo e le sponde.
In
assenza di interventi umani, la zona sarebbe interamente coperta da bosco, con
aspetti tendenzialmente xerofili sulle scarpate ed aspetti idrofilo-mesofili
sulle sponde a fondovalle.
Uno
sviluppo di attività rurali anche funzionali al massimo incremento della locale
“diversità biologica ed ambientale” vedrebbe la zona articolata in una serie di
habitat seminaturali sottoposti ad utilizzazioni più o meno intense: bosco
ceduo ad esclusiva partecipazione di specie autoctone, prati da sfalcio di
vario genere, coltivi di vario genere, orti urbani.
La soluzione progettuale risulta
essere la riqualificazione del parco pubblico mantenendo la funzione dell’area
a verde, dell’area sportiva, delle aree rurali, incrementando la fruibilità
delle aree, la naturalità dei luoghi e gli spazi dedicati alle funzioni
turistico-ricreative, sportive e agricole.
Il bosco presente lungo i versanti e i pastini risulta un
elemento determinante da valorizzare nello schema di progetto. La sua presenza
infatti fa da quinta tra l’area urbana e il parco della Valletta, mentre al suo
interno crea suggestivi panorami forestali autoctoni ed ornamentali. Forte
risulta l’influenza antropico-ornamentale delle specie vegetali presenti,
spunto di un mantenimento e sistemazione nel segno della storicità dei luoghi
(vecchi parchi e giardini storici delle ville austriache affacciati sul Corno).
Questi elementi di forza
rischiano di divenire un limite nel caso di un mancato intervento progettuale
che non ne renda attuabile l’accessibilità e la controllata manutenzione,
quindi permettendo lo sviluppo di eventi di marginalità e impenetrabilità che
ne limitano l’utilizzo all’uomo.
L’intervento consiste in una
completa manutenzione e pulizia del sottobosco rendento possibile il contatto
tra l’uomo e il verde. All’interno dei vecchi parchi storici si prevede anche
la potatura e interventi fitosanitari necessari agli esemplari arborei di
maggior pregio.
Si introduce così lo spettatore
a godere appieno del contesto globale.
I percorsi tematici nel verde affiancati da sporadici punti
panoramici di sosta, adeguatamente attrezzati per il riposo e sistemati in aree
strategiche verso le viste focali della vallata (la quota del pendio presenta
le condizioni ottimali per l’inserimento delle piazzole-vedette tematiche)
risultano essere fondamentali per stimolare l’ingresso al parco dei visitatori.
I percorsi, pedonali e ciclabili, dedicati a tutti i cittadini presenti
nell’intorno, dai semplici visitatori agli escursionisti, godranno del verde
dell’intorno, permetteranno di imparare e conoscere il territorio (attraverso
dei totem appositamente affrancati sulle “piazzolle tematiche” e illustrativi
della storicità dei luoghi e delle specie vegetali che caratterizzano il
bosco), permettendo al visitatore di sostare e mirare del paesaggio di un parco
rivitalizzato e a misura d’uomo.
Il percorso seguirà in quota il
torrente Corno lungo tutto il versante “sud”, terminando all’imbocco stradale
di via Brigata Casale (in prossimità dell’incrocio con via del Poggio), dove
ora si presenta in stati di abbandono vegetativo con sterpi e rovi a bloccare
l’accesso.
Il sentiero permetterà così un
totale attraversamento dell’area congiungendo i due estremi del parco.
Nella parte centrale, la sezione
ciclo-pedonale si incrocerà con il secondo asse di attraversamento del parco,
costituito dal prolungamento dell’asse di Vicolo del Guado e che discende fino
alla quota più bassa della depressione della Valletta, in linea con le quote
delle aree dedicate a prato e seminativo.
Questo asse, attualmente
presente e leggibile, consente l’attraversamento del corso d’acqua e congiunge
la parte sud del parco con quella a nord. Il percorso lega a se un primo
appezzamento di terreno coltivato ad orto (che costeggia il bordo abitato) con
il secondo sistema di appezzamenti del versante opposto. Questi ultimi
costituiranno la seconda parte dell’intervento, che punterà su uno sviluppo
intenso del verde a prato, con parti dedicate al seminativo e altre a
piantumazione di essenze floreali e cerealicole. Stimolante e di successo in
numerose città risulta la creazione di un’area dedicata agli orti urbani per i
cittadini, attrezzati con appositi box per gli attrezzi.
L’intenzione paesistica è quella
di creare un’alternanza di essenze lungo tutta l’area, in modo da mitigare il
paesaggio con differenti colori, a seconda delle specie e delle stagioni. Il
progetto non si limita però al solo impatto estetico ambientale, ma trova
ragioni nella altrettanto ambiziosa volontà di promuovere attività congiunte con la cittadinanza e le istituzioni
pubbliche, le cooperative e la didattica degli istituti che “colonizzano” i
bordi della Valletta. La tematica del “vivere il verde” porterà gli
attori-cittadini a contribuire nello sviluppo del verde, nella cura degli orti
e nel coinvolgimento degli spettatori che verranno chiamati a visitare ed a innescare
una piccola e nuova economia attraverso i prodotti e i risultati ottenuti.
Puntando sulla disciplina e le
tematiche di sensibilizzazione al verde, accogliendo un pubblico eterogeneo che
và dal bambino al pensionato, promuovendo attività di vendita diretta ed eventi
temporanei (da “celebrare” in appositi spazi dedicati ed allestiti), si
garantisce all’area una frequentazione continua giustificata dall’interesse di
creare dinamiche e scambio, emarginando il timore di interventi non fruttiferi
e che non colgano l’attenzione dello spettatore.
Dal punto di vista costruttivo,
i vari elementi che andranno ad essere realizzati nell’area del parco della
Valletta sono i seguenti:
–
portali di accesso di
viale Oriani: l’accesso al parco dal parcheggio pubblico già esistente su viale
Oriani viene ad essere individuato da due nuovi portali, realizzati in legno
lamellare e vetro serigrafato, da cui si accede alle due differenti parti del
parco. I portali, della lunghezza complessiva di 9m ciascuno, hanno struttura portante
realizzata in legno lamellare trattato in autoclave ( sezione rettangolare 15 X
30 cm ) ancorati a terra tramite piastre in acciaio zincato. La pavimentazione in
pietra locale identifica l’accesso all’area del parco. Le serigrafie sulla
copertura in vetro determinano il comporsi sulla pavimentazione del nome del
parco a seconda della luce solare che colpisce la copertura.
–
percorsi ciclopedonali: i percorsi, della
larghezza di 2,50m, vengono ad essere realizzati in ghiaino, con un trattamento
superficiale mediante emulsione bituminosa in grado di realizzare un fondo
solido, resistente all’acqua, ma con caratteristiche estetiche proprie di una
strada bianca. I margini dei percorsi saranno determinati dal posizionamento di
cordonate in pietra a spacco da 10cm di spessore.
–
Illuminazione dei percorsi: il progetto prevede di
effettuare l’illuminazione dei percorsi del sentiero di accesso dal passaggio
L.L. Zamenhof, di via del boschetto, del vicolo del Guado fino a viale Oriani,
di viale Virgilio e dallo stesso fino a vicolo del Guado. Verranno utilizzati
elementi luce di elevata qualità sia estetica che impiantistica, per illuminazione urbana
modello "Urban
Scene Philips CDP 702". Si ottenengono in questo modo dei percorsi
privilegiati di accesso al parco percorribili anche nelle ore serali.
–
piazzole di sosta: lungo i percorsi
ciclopedonali, come detto, vengono realizzate delle piazzole di sosta in legno
e pietra (in numero totale di 10). Di circa 5,90x5,70m di lato, sono dotate di
una rampa di accesso, sempre con fondo in tavolato di legno che permette di
raggiungere il piano posto rialzato di circa 60cm rispetto al terreno. Su di
esso vengono alloggiate due panchine ed il totem riportante descrizioni dei
luoghi e delle piante presenti.
–
centro informativo ed espositivo: il progetto prevede la
ristrutturazione dell’esistente edificio
in evidente stato di abbandono posto in prossimità dell’accesso di via Italico
Brass. L’ubicazione è tale da consentire l’utilizzo dello stesso sia come punto
informativo, espositivo e di ristoro, sia come punto di relazione per eventuali
manifestazioni che vengano ad essere organizzate nell’area del parco più
urbanizzata, verso viale XX Settembre. All’interno ed esterno dello stesso
verranno posizionate delle installazioni per fornire ai visitatori informazioni
sul parco, sulla sua storia e sulla flora e fauna in esso contenute. Trovano
posto nello stesso dei servizi igienici, di cui uno riservato ai disabili.
L’edificio è realizzato in modo da essere completamente accessibile agli stessi.
–
nuovo ponte di via del
Guado:
l’attuale attraversamento di via del Guado risulta essere inadeguato, sia dal
punto di vista idraulico sia da quello dell’integrazione
paesaggistico-ambientale. Si tratta infatti di tubazioni in cls poste sul fondo
del torrente con al disopra un getto di calcestruzzo che determinano un punto
di notevole perturbazione della portata e di possibile ostruzione dell’alveo.
Il progetto pertanto prevede di eliminare l’esistente manufatto, sostituendolo
con un ponte carrabile di luce pari a 9,00m realizzato in c.a. mediante spalle
in calcestruzzo gettato in opera e travi prefabbricate. Allo stesso viene ad
essere conferito un andamento ad arco ribassato con rivestimento in pietra
locale. La carreggiata, di 4,10m di larghezza utile, viene affiancata da
guard-rail in legno omologati che vengono mascherati verso l’esterno mediante
un reticolato di tondi in acciaio Ф18mm avente esclusivamente una
funzione estetica. Si realizza in questo modo una struttura ad elevata qualità
costruttiva, che ben si armonizza nel contesto locale. Questo quindi è l’asse
di accesso principale per i mezzi che dovessero accedere al parco per motivi
manutentivi.
–
ripristino ponte di via
del Boschetto: l’esistente ponte in pietra, di buone valenze paesaggistiche, risulta
attualmente degradato a causa del decadimento delle malte e dell’invasione
dello stesso da parte degli apparati radicali delle piante. Si provvederà
quindi al risanamento e restauro della struttura, salvaguardandone le
caratteristiche estetiche, garantendone la stabilità e posizionando sullo
stesso degli adeguati parapetti di protezione. Il ponte sarà transitabile
pedonalmente.
–
asfaltature delle strade
di via del Guado e del Boschetto: Per le due viabilità principali di accesso alle
due aree del parco si prevede, data la possibilità di un elevato traffico di
utenti ed anche di veicoli per la manutenzione, di procedere alla nuova
asfaltatura mediante l’esecuzione di uno strato di binder da 6cm e di un manto
di usura da 3cm di spessore.
–
area giochi per bambini: nel parco urbano già
esistente si prevede di realizzare un’area a prato dove vengono ubicati una
serie di giochi per bambini in legno, quali uno scivolo, un castello con torre
d’arrampicata e scivolo, un’altalena e dei giochi a molla, una funivia con
stazione di partenza ed arrivo.
–
predisposizione per orti
urbani:
al fine di consentire la fruizione del parco da parte dei cittadini di Gorizia,
si prevede di realizzare un’area predisposta a piccoli appezzamenti di orti
urbani. A tal fine questi verranno dotati di una piccola casetta in legno
porta-attrezzi e di una recinzione sempre in legno.
–
rifacimento scalinata di
via Virgilio: la scalinata in oggetto si presenta attualmente piuttosto degradata
nei materiali di rivestimento (palladiana con pietrame distaccato e corrimani
pressoché assenti). Pertanto se ne prevede il rifacimento, mediante una
pavimentazione in pietra locale squadrata posta su di una soletta da 10cm in
calcestruzzo. Le attuali cordonate che delimitano gli scalini, in discreto stato
di conservazione, verranno ad essere riposizionate. Infine si collocherà un
corrimano in acciaio verniciato.
–
interventi di sistemazione
del verde:
uno degli interventi principali da eseguirsi nell’area del parco della Valletta
è la manutenzione del verde, che presenta piante di notevole valenza immerse
però in un territorio in completo stato di abbandono. Si provvederà pertanto al
decespugliamento delle piante infestanti ed alla potatura dei cespugli e delle
essenze arboree presenti di cui si prevede il mantenimento. Verrà effettuata la
spollonatura al piede delle piante che necessitano dell’intervento, mentre le
piante che presentano problemi di stabilità o risultano non recuperabili
verranno abbattute, eliminando nel contempo le ceppaie. Si prevede inoltre di
procedere alla piantumazione di alcune essenze autoctone al fine di innescare
un processo di ricolonizzazione naturale e favorire lo sviluppo di un bosco
autoctono.
Concludendo, il progetto del
Parco della Valletta vuole mettere in relazione il parco stesso con la città,
il bosco con la realtà rurale, l’uso del verde con gli interessi del cittadino
e rendendolo protagonista del processo di riqualificazione e sviluppo. Tutto
questo sfruttando la presenza e la riqualificazione del corso del Corno, affiancandone
utili e non eccessive strutture di percorrenza, arredando nel rispetto totale
dell’intorno a vantaggio di un paesaggio da godere e dal quale poter imparare,
coinvolgendo attivamente chi lo attraversa.
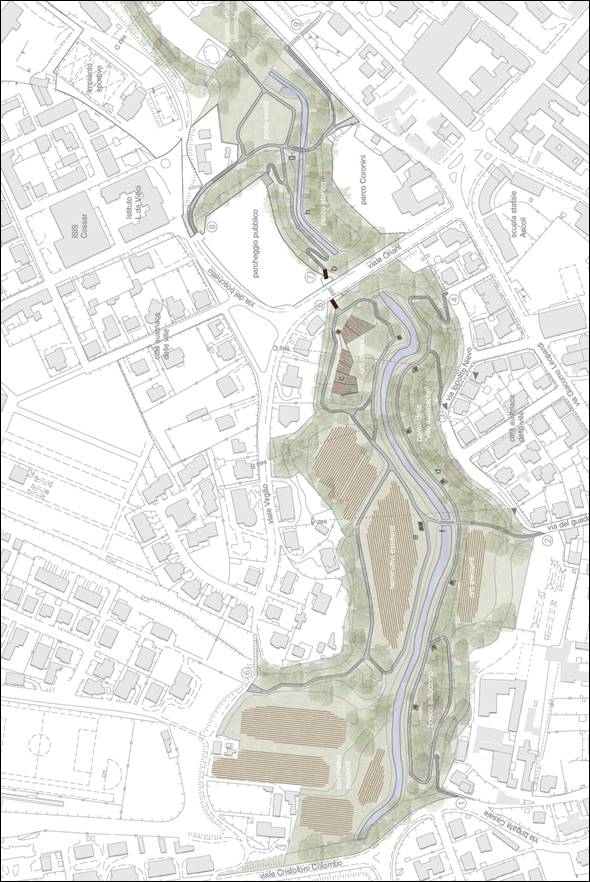
Figura 78: planimetria generale di
progetto della riqualificazione del parco della Valletta.
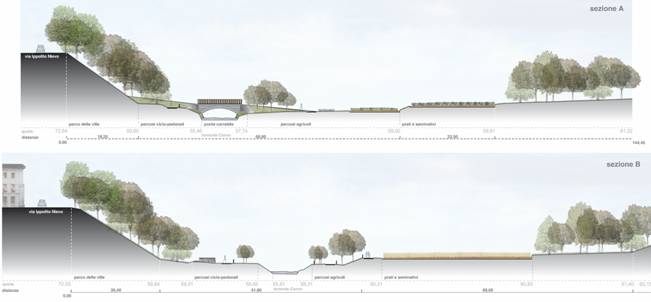
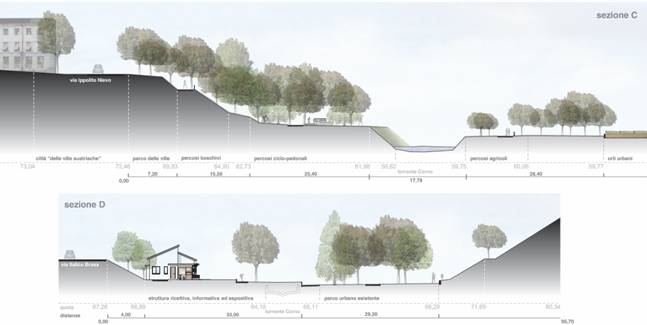
Figura 79: sezioni tipo (V.TAVOLA DI
PROGETTO ALLEGATA 3.7.2) di progetto della riqualificazione della Valletta.
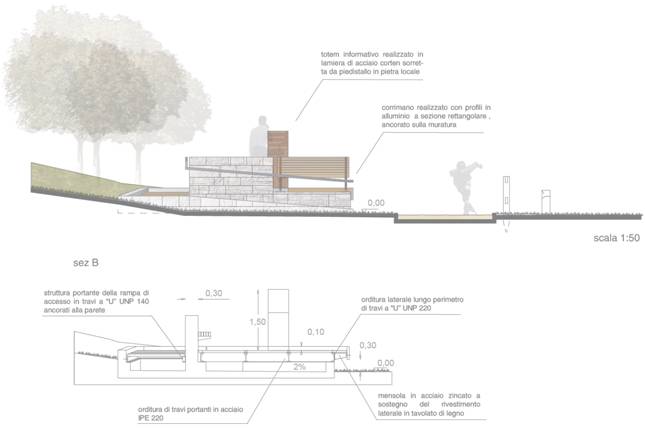
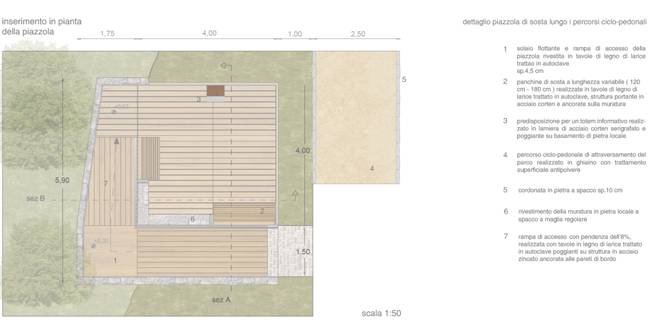
Figura 80: particolari delle piazzole di
sosta previste nel progetto, inserite lungo le piste ciclopedonali nel tratto a
valle di viale Oriani (V.TAVOLA ALLEGATA 3.7.4).

Figura 81: sezione tipo della pista
ciclopedonale all’interno del parco della Valletta (V. TAVOLA ALLEGATA 3.7.4)

Figura 82: esempio di pista ciclopedonale
in ghiaino con trattamento antipolvere di emulsione bituminosa, prevista
nell’intervento del Parco della Valletta.
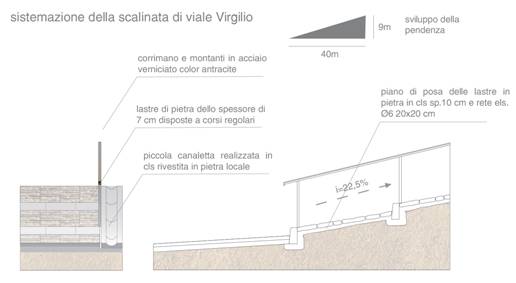
Figura 83: intervento di sistemazione
della scalinata pietra esistente lungo viale Virgilio (V. TAVOLA ALLEGATA
3.7.4)
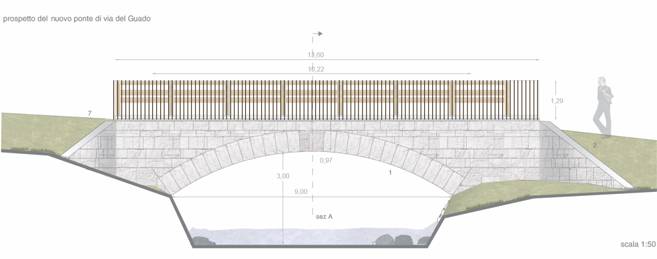
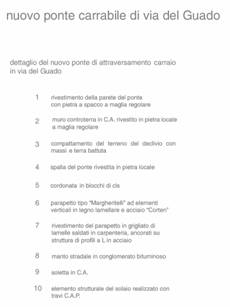
Figura 84: particolari del nuovo ponte
per l’attraversamento del torrente Corno, da realizzare lungo vicolo del Guado.
Le forme, le finiture e i materiali sono stati definiti per un armonico
inserimento dell’opera nel paesaggio della Valletta, richiamando gli elementi
già presenti come i muretti spondali in pietra locale e il vecchio ponte di via
del Boschetto, sempre lungo il Corno (V. TAVOLA ALLEGATA 3.7.4)

Figura 85: stato di fatto dell’edificio
da ristrutturare come punto informativo di ingresso e accoglienza al parco.
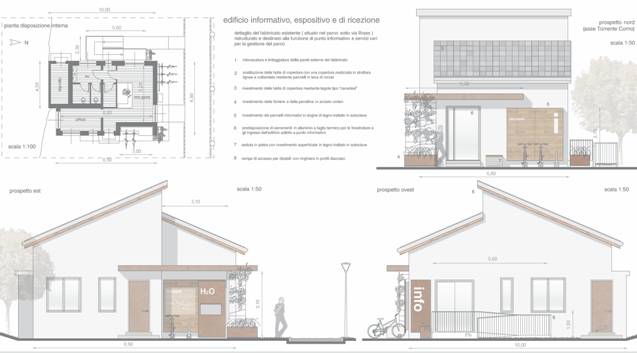
Figura 86: il progetto di sistemazione
dell’edificio esistente
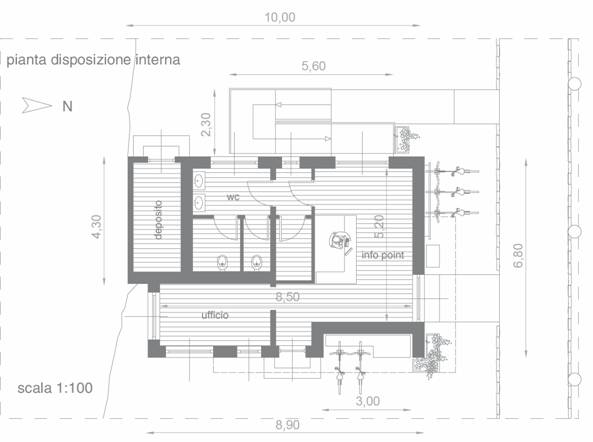
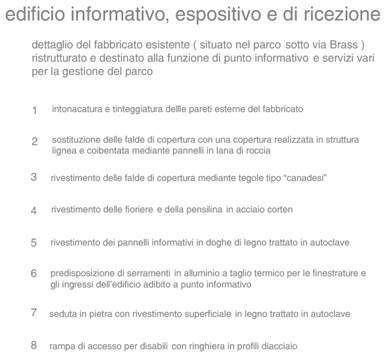

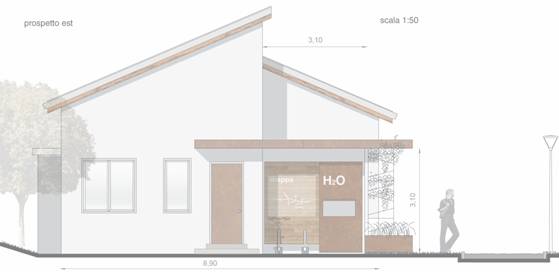

Figura 87: la ristrutturazione della
struttura esistente di ingresso e punto informativo al parco. La struttura a un
piano avrà la funzione di ricezione dei visitatori, punto informativo e di
illustrazione delle caratteristiche storiche della Valletta, della vegetazione
presente, della fauna e delle caratteristiche architettorniche delle ville
austriache affacciate lungo il Corno (V. TAVOLA ALLEGATA 3.7.5)
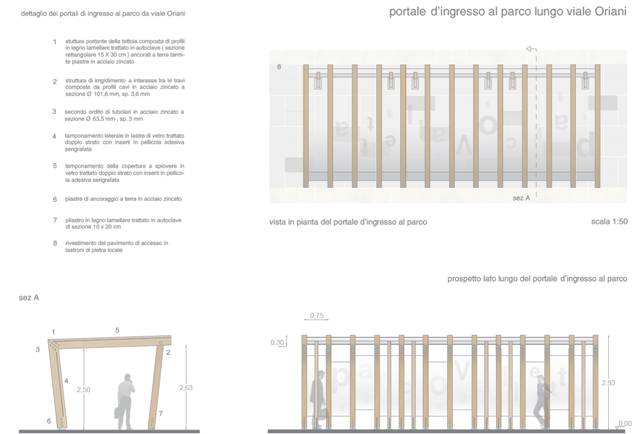
Figura 88: portali di ingresso in legno
lamellare da realizzare lungo il viale Oriani per l’ingresso al parco (V.
TAVOLA 3.7.5)

Figura 89: schizzi elaboati in fase di
progettazione per la percezione delle vie di ingresso, con portali, al parco
della Valletta dal viale Oriani
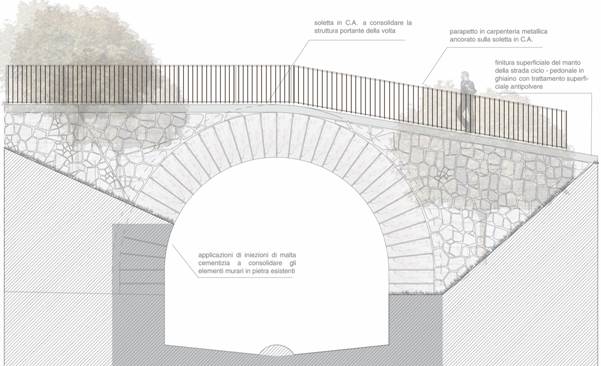
Figura 90: intervento di ristrutturazione
del ponte esistente in pietra naturale lungo via del Boschetto (V. TAVOLA
3.7.5)

Figura 91: esempio di pietra naturale
locale (arenaria) e di posizionamento a corsi orizzontali rinvenuta in
prossimità del parco della Valletta.